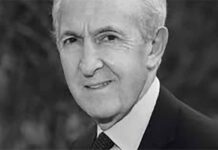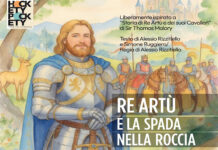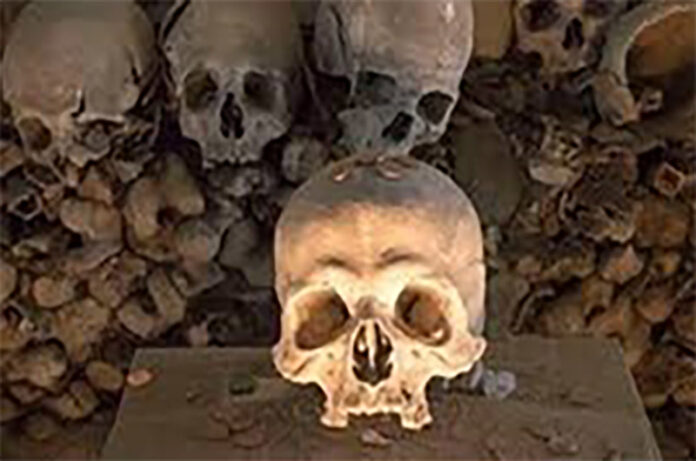Il 1855 fu per Viterbo un anno festoso e tragico. Alla fine di agosto venne inaugurato il teatro Unione con una stagione lirica e di balletto che merita ricordare: Viscardello di G. Verdi, Maria di Rohan di G. Donizetti, Roberto di Piccardia di G. Meyerbeer e il Fornaretto (Ballo Grande) con coreografie di G. Rota che vide la partecipazione della famosa ballerina americana Augusta Maywood. Il trionfo fu totale, anche per i consensi che ricevette il nuovo Teatro progettato da Virginio Vespignani, degno di una delle città più nobili dello Stato Pontificio.
Nei mesi successivi la città salì però alla cronaca anche per una ennesima epidemia di colera asiatico che provocò 304 morti in prevalenza anziani su 577 contagi. Uno dei focolai fu il monastero di Santa Rosa dove morirono 7 suore. Su ordine di due medici Giovanni Selli e Lorenzo Granati l’edificio e la zona circostante vennero isolati con barricate controllate giorno e notte.
I medici stessi si chiusero dentro per accudire le suore colpite dal morbo che in poco tempo venne debellato, ma non fu così per altre zone della città dove si registrarono, nel solo mese di novembre 1855, 20 decessi al giorno. Si dovette approntare un lazzaretto di fortuna in alcuni ambienti del Convento di Santa Maria in Gradi, affidato ai medici Luigi Serpieri e Francesco Fretz con l’assistenza di suor Giacinta Masini e del sacerdote Paolo Iannuccelli.
Il Comune guidato dal Gonfaloniere Luigi Cioffi stanziò una somma di 4.000 scudi per assicurare viveri ai poveri e per la pulizia delle strade che lasciava molto a desiderare. Ambienti e attrezzature sanitarie scarseggiavano, per cui in mancanza di una camera mortuaria le autopsie avvenivano addirittura all’aperto lungo le vie.
Come accadde con il Covid, si cercò di far tesoro di quella tragedia per taluni interventi strutturali, come la creazione nell’Ospedale Grande degli Infermi di Viterbo di un reparto speciale per potenziare cure e assistenza contro il colera, affidato ai medici Palemone Giannini e Vincenzo Nuvoli. Il servizio di assistenza fu svolto dalle suore di San Vincenzo de’ Paoli,
L’emergenza durerà a Viterbo per circa tre mesi con tutto quello che ne conseguì sul piano sociale ed economico. L’epidemia consigliò anche la realizzazione di un cimitero pubblico lontano dalla città. Venne scelta l’area di San Lazzaro di proprietà delle monache di San Simone. Fu incaricato lo stesso Virginio Vespignani di redigere il progetto, delimitare lo spazio con una cinta muraria, disegnare l’ingresso monumentale e l’area del Pincetto.
Va ricordato che Viterbo nell’Ottocento scampò miracolosamente ad altre epidemie di colera, piuttosto frequenti in quegli anni per l’accresciuta mobilità delle popolazioni. Citiamo (ma non furono le sole) quelle del 1837, 1854 e del 1865.
In tempi recenti, nel 1973, la città di Napoli ed alcune aree della Puglia vennero colpite dal colera che provocò 24 morti nel capoluogo campano e 9 in Puglia. Ci fu in quella circostanza una prova di grande efficienza sul piano della profilassi e nel giro di una settimana vennero vaccinate un milione di persone.
Sembra che l’epidemia fosse stata causata da un carico di cozze infette proveniente dalla Tunisia. In un primo momento finirono sotto accusa le cozze del golfo la cui richiesta, ovviamente venne azzerata, con gravi disagi economici per ristoratori e pescatori. Corsi e ricorsi della storia. In quel 1973 il presidente del Consiglio dei Ministri era mariano Rumor (coalizione Dc, Psi, Psdi e Pri) e sindaco di Napoli Gerardo De Michele, peraltro un medico di grande valore.
L’autore*
Console di Viterbo del Touring Club Italiano. Direttore per oltre trent’anni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Viterbo (poi Apt). È autore di varie monografie sul turismo e di articoli per riviste e quotidiani. Collabora con organismi e associazioni per iniziative promo-culturali. Un grande conoscitore della Tuscia.