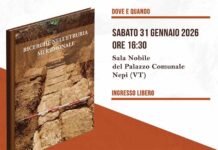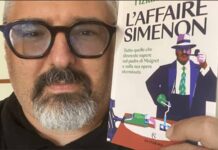C’era una volta… «Un re!» diranno subito i nostri lettori. Potremmo iniziare così, con l’incipit de “Le avventure di Pinocchio”, la celebre fiaba di Carlo Collodi. Invece diremo che ci sono un paese, una scuola e un burattino. Il borgo è quello di Farnese, una perla arroccata su uno sperone di tufo alla periferia nord della Tuscia, lambita dal verde profondo e misterioso della Selva del Lamone. Il paese porta il nome della famiglia che fu genius loci rinascimentale dell’intera Tuscia. La sua scuola elementare si erge su Corso Vittorio Emanuele, il grande viale diritto che conduce al cuore del paese. E’ maestosa, dalle linee un po’ severe, con grandi gradinate esterne. Tra le sue mura adesso c’è silenzio. Per il calo demografico e l’accorpamento degli istituti, oggi i bambini di Farnese vanno alle elementari a Ischia di Castro. Ma non c’è malinconia: briciole dorate di magia dell’infanzia si trovano ancora nell’ex scuola sul viale. Qualcosa è restato, capace di trovare una chiave di accesso al mondo degli adulti, con la poesia e il colore di una fiaba senza tempo: Pinocchio. In alcuni locali della scuola, un gruppo di donne innamorate del burattino di Collodi ha dato vita a un particolarissimo museo: il primo e unico dedicato a “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini. Il perché è presto detto: nel 1971 Comencini girò gran parte delle riprese del suo Pinocchio proprio qui a Farnese. Lo sceneggiato – come si chiamava allora – andò in onda l’anno successivo. Le avventure del burattino, impersonato nella sua versione “umana” dal piccolo Andrea Balestri, le gesta di attori celebri come Nino Manfredi nella parte di Geppetto, Ciccio e Franco indimenticabili Gatto e la Volpe, Gina Lollobrigida come una sensuale e materna Fata Turchina, entrarono nell’immaginario collettivo di una nazione ancora giovane, che scopriva la propria identità comune anche grazie alla televisione. La colonna sonora scritta da Fiorenzo Carpi divenne celebre.
«Credo che Comencini abbia realizzato una vera opera d’arte qui a Farnese». A parlare è Anna Michelina Ferrari, farnesana doc. E’ lei la presidente dell’associazione “Gli amici del borgo di Pinocchio”, nata di recente per promuovere Farnese come luogo di cinema. «Qui a Farnese è stato realizzato il primo set, girato il primo ciak. Qui è stata proiettata la “prima”. Molti compaesani recitarono, come comparse o comprimari. C’è un fortissimo legame di ricordi condivisi tra Pinocchio e gli abitanti del borgo». Durante i mesi delle riprese, gli attori e la troupe vissero a Farnese risiedendo presso famiglie del luogo, in una dimensione semplice e ancora legata ai ritmi della terra. «Io avevo solo sei anni. Mia mamma portava me e i miei fratelli a vedere le riprese. Andrea Balestri, il piccolo protagonista, stava a casa di mia zia. Quando non studiava e non lavorava sul set, giocava con noi bambini. Era veramente un Pinocchio, vivacissimo e ribelle. Adorava il trattore di mio padre!». Michelina è appassionata di tutto ciò che riguarda il burattino e lo sceneggiato di Comencini. «Ancora oggi che sono grande, quando sento la musica della colonna sonora, mi commuovo». Ma com’è iniziato il sodalizio tra Farnese e Comencini? «Un giorno arrivò qui lo scenografo e costumista Piero Gherardi in compagnia di un tecnico della troupe, entrarono in una tabaccheria e dissero che stavano cercando delle ambientazioni per poter girare uno sceneggiato. Di fuori c’era Pietro Gentili, il compaesano che poi avrebbe impersonato il carabiniere. Li accompagnò lui stesso alle varie possibili location: il ponte antico sul fiume Fiora, le stalle di Sant’Umano, con all’esterno i mucchi di paglia e di stabio. Comencini stava cercando un ambiente poverissimo dove situare la casa di Geppetto, e quelle stalle facevano proprio al caso suo. In tutto vennero selezionati quattro o cinque set diversi nel paese e nelle campagne circostanti».
Nell’ottica di una valorizzazione del territorio in senso turistico, il comune di Farnese ha di recente puntato molto su Pinocchio. Per il cinquantenario delle riprese, con la collaborazione dell’associazione veneta Archi-VA, promotrice del progetto “Vivere le favole “, l’amministrazione comunale ha invitato artisti da ogni parte d’Italia per dipingere le porte dell’antico borgo con soggetti a tema, e realizzato la bottega, il carro e la casa di Geppetto.
Mentre cinque farnesane, cinque “fatine Turchine”, hanno creato un’associazione senza scopo di lucro, “Gli amici del borgo di Pinocchio”, e inaugurato il museo “Le avventure di Pinocchio”, nato come piccola mostra, ma con l’ambizione fin da subito di diventare permanente. «L’anno scorso il romanzo di Collodi ha compiuto centoquarant’anni, essendo stato pubblicato per la prima volta nel 1883. Abbiamo proposto una mostra itinerante dedicata a Collodi. Hanno aderito otto comuni dell’Alta Tuscia – Acquapendente, Bolsena, Latera, Ischia, Capodimonte, Marta, Cellere e la nostra Farnese. La mostra è partita ad agosto e si è conclusa a dicembre. Per allestirla, abbiamo iniziato a ricercare il materiale: ne abbiamo trovato tantissimo. Tutto ciò che riguarda Pinocchio, partendo dal film, che è rimasto nel cuore di tutti». Nelle sale adibite a museo vi è un caleidoscopio di colori e di luce, di sensazioni, di curiosità, di immagini a noi carissime. Un allestimento curato con amore, di locandine cinematografiche, libri, burattini di ogni foggia e tinta, fumetti, giocattoli, attrezzi da artigiano e da contadino: oggetti donati, ma anche e soprattutto acquistati dall’associazione. Ciascuno corredato da un commento in dettaglio. «Siamo partiti dalle locandine del nostro film in italiano, per trovarne poi altre in spagnolo, in tedesco, in ebraico – è stato trasmesso in moltissimi paesi del mondo. Man mano che la ricerca andava avanti, abbiamo trovato un mondo intero. Abbiamo scoperto che Pinocchio è stato tradotto in vari dialetti italiani – come il veneziano, il pugliese, il genovese, compreso il farnesano! Nel nostro museo sono presenti versioni in dialetto, in poesia, anche molto antiche e pregiate. E ci sono le traduzioni in ogni lingua del mondo, dall’arabo al franco-provenzale, dall’ucraino all’ebraico, dal cinese all’afrikaans». Nel museo si possono ammirare vecchie edizioni della Domenica del Corriere, fumetti, raccolte di figurine, opere minori di Collodi, vinili musicali. Alle pareti, foto del periodo delle riprese, con gli attori che si mescolano agli abitanti di Farnese. E le foto dell’inaugurazione, con i padrini del museo, Giampiero Ingrassia e Massimo Benenato, i figli degli indimenticati Ciccio Ingrassia e Franco Franchi. Tanti burattini, seduti o in buffe pose, sculture realizzate da valenti artigiani del legno. «Alcuni burattini ci sono arrivati da Agrigento, dalle Marche, perfino dagli Stati Uniti. E’ arrivato talmente tanto materiale, che quasi non c’è più spazio. Vorremmo realizzare altri ambienti, come l’osteria e la scuola». Anche perché l’associazione raccoglie ancora il materiale che dovessimo avere nelle nostre case, e a cui volessimo regalare una nuova e prestigiosa collocazione. «Abbiamo il patrocinio di Tuscia Film Festival, e della Fondazione Nazionale Collodi. E collaboriamo con le scuole, sia della provincia di Viterbo che di Roma».
Michelina Ferrari è un vulcano di idee e di progetti, e insieme alle sue colleghe, tiene aperto il suo piccolo museo ogni sabato e domenica, dalle 10.30 alle 12 e trenta, e dalle 16 alle 18. Stringe a sé il burattino, mentre ci racconta con orgoglio le espressioni di meraviglia sui volti dei molti visitatori. Anche e soprattutto degli adulti. Perché per i bambini di ogni epoca, il burattino di Collodi è un personaggio speciale. Ma, come cantava Johnny Dorelli, per gli adulti Pinocchio è “carissimo”.
.