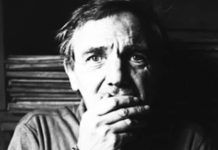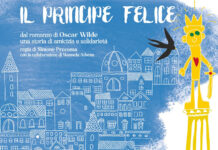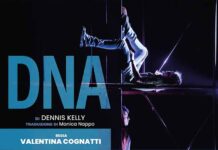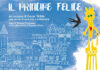E’ molto salutare la “pillola” di questa settimana dedicata a Bassano Romano, borgo nobile e appartato nel versante sud del Viterbese, tra i laghi di Vico e Bracciano, a una cinquantina di chilometri da Roma, dove fanno notizia la riapertura del palazzo Giustiniani, dopo lunghi e provvidenziali restauri, e una statua marmorea attribuita a Michelangelo nella chiesa di San Vincenzo annessa al santuario del Volto Sacro di Gesù.
In tutte e due i casi c’è lo zampino di Vincenzo Giustiniani (1564-1637), marchese, banchiere, intellettuale e collezionista di opere d’arte, genovese di stirpe, ma romano di spirito e di adozione. Dopo aver acquistato il castello (già degli Orsini e degli Anguillara) al centro di Bassano Romano che trasformò in un aristocratico palazzo, mise mano ad un progetto di ristrutturazione del borgo di cui oggi si avvalgono abitazioni e viuzze annerite dalla storia che conducono in spontanea armonia alla cosiddetta “Pujarella”, la piazzetta centrale del paese che a luglio insieme alle altre si trasforma in un emporio a cielo aperto d’altri tempi con i “Mercatini del Seicento”. Se vi trovate a Roma, il marchese vi aspetta nella cappella di famiglia all’interno della basilica di Santa Maria sopra Minerva.
Federico Fellini probabilmente lo ha fatto, prima di girare alcuni esterni della “Dolce vita” (1959-1960) nel palazzo Giustiniani per trarre ispirazioni soprattutto nella scena della “festa dei nobili”, con tanto di Marcello Mastroianni, sullo sfondo del casino di caccia. all’interno del parco. Tonino Cervi non gli fu da meno con l’Avaro di Alberto Sordi (1989-1990). Per la serie curiosità aggiungiamo “ Il Gattopardo” di Luchino Visconti (1963), il “Blaise Pascal” di Roberto Rossellini (1972), “Il Marchese del Grillo” di Mario Monicelli (1981), “Bianco, Rosso e Verdone” (1981), “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni.(2007) e altri.

Ed eccoci al cospetto del palazzo, segnalato da tre mega piedistalli in peperino presso l’ingresso che sostengono le teste marmoree dette in dialetto locale “Tatocci di piazza”. Erano quattro, ma uno non c’è più. Entriamo. Lo scalone è solenne. Al piano nobile si apre una serie di stanze e camerini, che insieme alla loggia (colorata di grottesche), la galleria, lo studiolo e la cappella, propongono una sequenza di affreschi sei-settecento a firma di vari artisti tra cui Antonio Taverna, Domenichino, Bernardo Castello, Prospero Orsi, Paolo Guidotti Farnese ed altri. Notevole il grande dipinto di Francesco Albani che racconta il mito di Fetonte, narrato nel secondo canto delle Metamorfosi di Ovidio, con accanto le rappresentazioni delle nefaste conseguenze sulla terra: i boschi bruciano, Galatea fugge con il suo seguito, Nettuno appare in preda all’ira sul suo carro, le acque si ritirano scoprendo i corpi delle sirene.
Pregevole nella cappella il busto di Innocenzo X opera in terracotta di Alessandro Algardi. La Rocca all’interno del parco col giardino all’italiana porta la firma di Carlo Maderno. Un prezioso cammeo è la riproduzione di un teatro shakespeariano con i loggioni in legno (conteneva fino a 200 posti) disposti in semicerchio.
Fa anche notizia, come dicevamo all’inizio, la statua del Cristo Portacroce nella chiesa di San Vincenzo annessa al santuario del Volto Sacro di Gesù poco fuori l’abitato. Sulla scultura c’è un mistero legato a Michelangelo che l’avrebbe iniziata nel primo Cinquecento su commissione di alcuni nobili del tempo per la Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma. Avrebbe interrotto il lavoro a causa di una venatura del marmo in pieno volto. Per onorare l’impegno Michelangelo realizzò un’altra statua con l’aiuto, secondo Antonio Vasari, di un suo allievo, tale Pietro Urbano. Addirittura ne avrebbe fatta una terza poiché quella di Urbano non andava bene.
L’opera incompiuta venne acquistata molti decenni dopo, nei primi del Seicento, con apprezzabile intuito, da Vincenzo Giustiniani e poi posizionata dai suoi eredi nel Santuario di Bassano Romano, con l’aggiunta di un perizoma come comandava la Controriforma. Fu merito di una studiosa, Silvia Danesi Squarzina, se nel 2001 rileggendo alcuni documenti potè ricostruire la storia di quella scultura, con la sua nervatura come marchio di riconoscimento. Venne accuratamente ripulita, privata del perizoma e sistemata nella chiesa di San Vincenzo. Cristo è in piedi appoggiato a una croce. Il suo corpo è perfettamente modellato con una torsione che molto appartiene alle soluzioni michelangiolesche.
Per le vostre preghiere c’è anche il patrono San Gratiliano martire, decapitato nel IV sec. e ricordato a metà agosto a Bassano Romno con feste popolari e religiose, la cui reliquia è custodita in un busto d’argento nella parrocchiale del’Assunta.
Nella cover, una sala del piano nobile di palazzo Giustiniani
L’autore*
Console di Viterbo del Touring Club Italiano. Direttore per oltre trent’anni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Viterbo (poi Apt). È autore di varie monografie sul turismo e di articoli per riviste e quotidiani. Collabora con organismi e associazioni per iniziative promo-culturali. Un grande conoscitore della Tuscia.