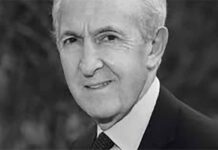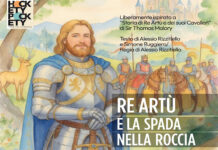Tra il Mille e il 1500 Viterbo produceva lino e canapa di buona qualità, utili sia al fabbisogno familiare, che alla vendita nei mercati limitrofi. Avrebbe conteso addirittura a Napoli il titolo di campione d’Italia per la qualità del lino. Quando era in fioritura – scrive Pio II Piccolomini nei suoi Commentari – il Piano dei Bagni, alle porte della città, si trasformava in un tappeto azzurro.
Nei secoli successivi queste coltivazioni non vennero mai abbandonate completamente. Prima dell’ultima guerra, intorno al 1940, la loro coltivazione, che si alternava a quella del grano in un razionale sovescio, era ancora diffusa come del resto in molte altre regioni d’Italia, con l’effetto di influenzare anche stili di vita, rapporti, sociali. Perfino familiari, considerata la folta partecipazione di manodopera femminile.
Oggi di tutto questo patrimonio agro-culturale non è rimasto più nulla, ma non è escluso che non si possa riparlarne, in una visione di agricoltura più sostenibile e di transizione ecologica. La lettura di alcune gabelle comunali del centro Italia, in particolare Siena, Roma e Perugia, ci informa che l’export era florido, tanto che il comune di Viterbo, come si legge negli statuti comunali a partire dal XIII sec., controllava la semina, il raccolto e soprattutto la macerazione nelle vasche adiacenti alle sorgenti di acqua sulfurea.
L’addetto alla macerazione era conosciuto come il “piscinario”, una sorta di guardiano delle vasche che dettava i tempi per l’ammollo nelle pozze. Con alcuni sodali sorvegliava tutta l’area di Pian dei Bagni, piuttosto affollata durante il raccolto e la lavorazione. Lo scenario non sfuggì a Dante quando probabilmente lo vide di persona o ne sentì parlare nel Trecento nel suo viaggio a Roma, tanto da servirsene per una doppia terzina del XIV Canto dell’Inferno. A margine dei ruscelli pietrosi sostavano le “pettatrici” a macerare la canapa, o le “peccatrici” secondo altre interpretazioni.
Lino di qualità e canapa extrabianca. Merito della terra asciutta e grassa intorno alle sorgenti ipertermali che alimentavano una trama fumosa di rivoli e laghetti. Ingredienti naturali ed esclusivi per la macerazione degli steli che venivano poi fatti asciugare al sole. A volte riuniti a fasci di forma conica come le tende da campo. Si procedeva poi alla battitura con mazze e bastoni per una prima e sommaria separazione della fibra dalle cortecce.
In questa fase di lavorazione erano abili gli “scotolatori” che a colpi di coltellacci di legno (le viterbesi “scotole”), eliminavano le scorse legnose prima della “pettinatura”, dando allo stelo la giusta curvatura. Il termine “scotolatori” è entrato nella storia di Viterbo, nel dialetto, nel carattere dei suoi abitanti e nel vissuto locale, tanto che la comunità ha loro dedicato una via nel quartiere di Pianoscarano. Categoria privilegiata e affidabile, se è vero che veniva loro consentito di lavorare anche di notte, con tutti i rischi del caso.
Infine le “pettinatrici”, parrucchiere ante litteram, con mani più callose e meno raffinate delle acconciatrici di oggi, ma altrettanto abili a dipanare le matasse fibrose. Buona presenza dunque di manodopera femminile, una rarità per quei tempi in cui la donna non contava molto, relegata com’era a cucinare e fare figli. La prospettiva delle più giovani era di guadagnare per farsi la dote.
Una preziosa campionatura degli attrezzi usati, compresi un telaio e alcune foto bianco-nero degli anni Trenta-Quaranta, è provvidenzialmente custodita a Viterbo in un antro del quartiere di Pianoscarano accanto a un antico frantoio (visitabile su richiesta). La troviamo anche nel Museo della Civiltà Contadina e delle Tradizioni Popolari nella vicina Canepina, un borgo di antiche tradizioni lungo la strada Cimina. A proposito di Canepina, va ricordato che un panno di canapa, entra ancora oggi nel processo di scolatura dei tradizionali “maccaroni” (il cosiddetto “fieno”) una specialità del posto. Per disidratarli, prima di insaporirli con la salsa di pomodoro, vengono versati e stesi su un panno di canapa.

Va aggiunto che nel Quattrocento, ma non solo, molte famiglie viterbesi si sostenevano con la produzione di lino (ottimo l’olio per cucinare, alimentare le lampade e preparare i cataplasmi) e di canapa con cui si confezionavano oggetti di uso comune, cordami per vari usi e i “fiscoli” per la molitura dell’olio d’oliva.
Però quanto fetore. Canapa e lino macerati nell’acqua erano così maleodoranti che un pontefice, al tempo della sede papale a Viterbo, pretendeva che tutta la lavorazione delle fibre avvenisse fuori dalle mura cittadine, al Piano dei Bagni che nei mesi di lavorazione del raccolto, da giugno ad agosto, complice anche il percorso della Francigena, si trasformava in una borgata, con tanto di capanni e osterie, frequentata da lavoratori, mendicanti, ladruncoli, pellegrini, prostitute, mercanti e imbroglioni.
Nella foto cover, un campo di lino
L’autore*
Console di Viterbo del Touring Club Italiano. Direttore per oltre trent’anni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Viterbo (poi Apt). È autore di varie monografie sul turismo e di articoli per riviste e quotidiani. Collabora con organismi e associazioni per iniziative promo-culturali. Un grande conoscitore della Tuscia.