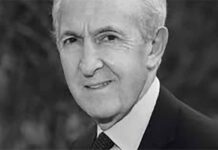Mi capita sotto mano la tesi di laurea in “Restauro architettonico” di Loredana Vitiello (relatore Giovanni Carbonara) dal titolo “Il parco archeologico-paesaggistico di Norchia” che ripropone l’annosa questione di un sito di rara importanza, chiamato addirittura la Petra della Tuscia, ma poco conosciuto e valorizzato. Una delle cause è la difficoltà di accesso, dal momento che è circondato da alcune proprietà private. Si trova sulla via Clodia tra Blera e Tuscania (Lazio) e occupa un pianoro alla confluenza dei fossi Pile e Acqualta, nel fiume Biedano.

Vitiello ci ricorda che fu un centro abitato dall’età preistorica al tardo Medioevo. Le ultime notizie risalgono al primo trentennio del Quattrocento, quando scomparve forse a seguito di una guerra tra popolazioni locali. Va ricordato, aggiunge Vitiello che la città di Norchia è in un lacunare del soffitto della sala Regia del palazzo dei Priori di Viterbo dipinto da Tarquinio Ligustri nel 1587, raffigurata nell’aspetto di un borgo medioevale cinto da mura turrite e dominato dalle moli di un castello, di una torre e di una chiesa.
Molte le tracce dei secoli passati. Alcune – annota l’autrice – ci riportano al nomadismo quando venivano utilizzati percorsi di crinale “a piede asciutto” secondo una colorita terminologia, fino allo sviluppo delle grandi civiltà dotate di una organizzazione tecnico-civile tale da ottenere la massima produttività della pianura attraverso una elevata artificialità di strutturazione. In epoca etrusca Norchia era compresa nella lucumonia di Tarquinia.
In età romana – si legge nella tesi – venne praticamente abbandonata per essere di nuovo frequentata dopo la caduta dell’impero. Una rara testimonianza di quel periodo sono i resti di un ponte e di un mausoleo di tale Clodius Titus. L’intendimento dell’autrice è quello di suscitare nuovi interessi per trasformare tutta l’area in un parco archeo-naturale, dal momento che le sue vestigia tra tufi millenari fanno anche parte di un paesaggio e di una natura di raro interesse.
Il documento passa poi a esaminare la parte di territorio legata all’allevamento della razza maremmana allo stato brado tra macchie e radure dove non è possibile la coltivazione agricola. “Con l’istituzione del parco – sostiene l’autrice – il bosco assumerebbe una funzione nuova poiché passerebbe da quella attuale – inserita in un’economia agro silvo-pastorale di sopravvivenza nell’ambito della quale si forniscono legna da ardere, materiale per usi agricoli, pascolo e ombra per il bestiame durante il periodo estivo – a quella di uno spazio di ricreazione psico-fisica a visitatori per mezzo di iniziative turistico-culturali”. Le annotazioni sono utili a una progettualità di parco da tutti auspicata.
Ma la vera attrazione – ricorda Vitiello – è l’area archeologica che comprende ripari preistorici, tombe etrusche rupestri, ruderi romani una via cava e resti dell’abitato medioevale. In questa zona i valori propri della vegetazione naturale si fondono con quelli archeologici e con quelli estetici che risultano dalla particolare morfologia del territorio. Questa unità va conservata e per questo va escluso ogni tipo di taglio; l’unica eccezione ammessa è quella rappresentata dagli interventi conservativi della necropoli. Questi possono comportare l’eliminazione di alberi o arbusti che direttamente o indirettamente danneggiano le opere murarie.
“Gli interventi finalizzati al recupero produttivo e salvaguardia ambientale – aggiunge l’autrice – dovrebbero essere ovviamente la stesura di un progetto di restauro dei singoli settori archeologici e sua attuazione mediante rigorose operazioni di scavo, rilievo, restauro e consolidamento, organizzazione di percorsi per la visita e organizzazione di zone attrezzate per permettere la fruibilità da parte di persone con impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale”.
Norchia, “Le bella addormentata” parafrasando la fiaba dei fratelli Grimm, più che una pillola è un cammeo nella campagna della Tuscia viterbese e ci attendiamo un suo risveglio per consolidare nuove proposte esperienziali di un turismo sempre più orientato alla mobilità lenta e al rispetto per la natura.
Nella cover, ruderi della pieve di San Pietro
L’autore*
Console di Viterbo del Touring Club Italiano. Direttore per oltre trent’anni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Viterbo (poi Apt). È autore di varie monografie sul turismo e di articoli per riviste e quotidiani. Collabora con organismi e associazioni per iniziative promo-culturali. Un grande conoscitore della Tuscia.