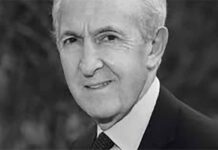“Stracciarolo donne!”. Grido festoso e rassicurante più volte udito negli anni Cinquanta lungo il viale Quattro Novembre a Viterbo nel quartiere dei Cappuccini. Il suo carretto ripieno di struffaglie per la casa, procedeva lentamente, a passo d’uomo, subito circondato da un nuvolo di ragazzi chiassosi. Le donne sapevano del suo passaggio ed erano pronte a scendere in strada con vecchi indumenti, panni non più utilizzati, coperte sdrucite e altro per barattarli con utensili da cucina: bacinelle, cuccumelle, piatti, bottiglie, vasi e quant’altro che lo “stracciarolo” teneva a penzoloni nel suo carretto.
Passaggi meno frequenti quelli dell’arrotino, a cavallo di una bicicletta trasformata in mini-officina mobile. Mentre pedalava da fermo su un traballante cavalletto, metteva in azione con una cinghia di cuoio un marchingegno terminante in una ruota di pietra abrasiva che girava velocemente, su cui affilava coltelli e coltellacci, forbici, rasoi, accette, roncole. Ingegnoso e funzionale quel barattolo arrugginito ripieno d’acqua posto nella parte più alta del biciclo, da cui cadeva regolarmente attraverso un budelletto una goccia che andava a spegnere le scintille provocate dall’attrito delle lame sulla “mola”.
Decisamente più creativi lo scalpellino e il “tornaro” (tornitore). Il primo dotato di martello e scalpello lavorata il peperino o il marmo ricavandone fregi e ornamenti, figure umane, statue cimiteriali, vasi da giardino, fontane e fontanili, immagini sacre. Uno di loro ha addirittura riprodotto in scala ridotta agli inizi del secolo scorso la fontana Grande di Viterbo che poi venne sistemata nella piazza antistante il comune di Rodi, dove si trova tuttora.
Stessa abilità per il “ tornaro” che con il legno, una sgorbia e un tornio era capace di creare vere e proprie opere d’arte accanto ad oggetti e arredi d’uso domestico, come gambe di tavoli, finestre, “ruzzoloni” e, per i più giovani, “stornavelli”, giocattoli ed altro. A Viterbo le botteghe più storiche si trovavano in via Saffi e in via Mazzini.
Molto richiesti in determinati periodi dell’anno i servizi dell’ombrellaio, abile anche a rimettere insieme i cocci di vasellame. Sempre negli anni del dopoguerra ai Cappuccini, ce n’era uno che portava a tracolla una cassettina di legno con attrezzi e ricambi: trapano, qualche bacchetta, alcuni manici d‘osso finto, filo, colla, grappette di ferro, pezzi di stoffa nera. Si faceva sentire con la sua voce roca “Ombrellaio donne. Piatti, ombrelli, concoline, ziri e schifetti da accomodar”. Le donne s’affacciavano sull’uscio di casa a contrattare le riparazioni di un ombrello, di un bacile o di una brocca.
Maggiore impegno per i “canestrari”. Mi vengono in mente Luigi Cutigni di Viterbo (in arte Patacchino) , Zefferino di Pianoscarano, Ovidio Cima di Bagnaia (peraltro mio cognato), Guido della Gasperina di Bagnaia ed altri. Materia prima le fruste che si ottenevano da vari ramoscelli di piante, come il salice, il nocciolo selvatico, l’olivo, l’olmo, il giunco e la canna. In genere le forme dei canestri erano circolari, a tronco di cono rovesciato, con o senza manico. I nomi erano riferiti al loro impiego: capagno, capagnolo, capagnone. Ideali per raccogliere funghi, nocciole, olive, castagne, e frutta, comprese le more selvatiche.
Ho conosciuto e frequentato Idolando il “bottaro” nel suo antro-bottega di Bagnaia. La sua abilità stava nel piegare le toghe con una lunga preparazione a fuoco e di fissarle alla base prima di avvolgerle nei cerchi di ferro. Armamentario di attrezzi altamente funzionale: il “raschio” per pulire all’interno le botticelle e le “cupelle” (quelle più piccole), la “fallega”, una pialla per levigare la faccia concava delle doghe, la mazzuola, l’ascia curva, da carpentiere e altro.
Una stirpe di “bottari” si trovava a Canepina, poco distante da Viterbo, sui colli Cimini, dove esiste addirittura il vicolo dei Bottari. Fino a qualche anno fa vi si costruivano tini, botti e bigonci alcuni dei quali sono finiti nel locale museo delle tradizioni popolari. Questi vetusti contenitori che la muffa delle cantine rendeva biancastri e odorosi, venivano in tarda estate puliti presso le fontane delle piazze a suon di robusti risciacqui. Per immortalarne il rito che rallegrava gli angoli del quartiere di Pianoscarano a Viterbo, viene da anni riproposto il palio delle botti.
Lo chiamavano “Il falchetto” e faceva il carrettiere, specializzazione molto richiesta in quegli anni del dopoguerra in cui i collegamenti non erano agevoli. Con il carretto dal pianale senza sponde, trainato da un cavallo borso e mansueto, trasportava un po’ di tutto sul tratto Bagnaia-Viterbo: mattoni, travi di ferro, sacchi di cemento, mobili, vettovaglie ed altro. “Falchetto” era cordiale, dal fisico asciutto, sempre in canottiera e permetteva ai ragazzi di salire sul pianale per fargli compagnia lungo il tragitto. Durante le soste approfittava per foraggiare il cavallo con un sacco appeso al collo pieno di biada e altre granaglie.
Nella foto, il “bottaro”
L’autore*
Console di Viterbo del Touring Club Italiano. Direttore per oltre trent’anni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Viterbo (poi Apt). È autore di varie monografie sul turismo e di articoli per riviste e quotidiani. Collabora con organismi e associazioni per iniziative promo-culturali. Un grande conoscitore della Tuscia.