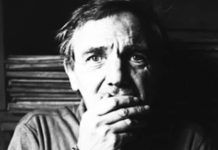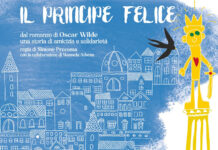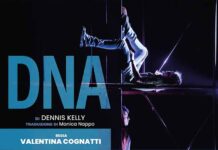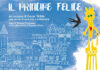Prosegue l’itinerario rivolto a evidenziare la precarietà di conservazione e tutela delle porte urbiche viterbesi.
Dopo il precedente articolo, dedicato all’incuria nella quale versa statutariamente Porta Faul, esempio del nuovo concetto di “giardino verticale urbano” concepito per accogliere l’insorgenza delle piante infestanti, è ora la volta di Porta Romana oggetto di restauri integrativi, per usare un eufemismo, di sostituzioni e di paradossali dimenticanze.
In primo luogo alcune notizie storiche in sequenza cronologica che stridono con la risibile rilevanza attribuita dagli attuali amministratori a un monumento di fatto bistrattato, al quale si guarda con fugace attenzione forse soltanto in estate, quando vengono montate le impalcature della macchina di Santa Rosa in vista del tradizionale trasporto del 3 settembre.
L’accesso cittadino da e per Roma insiste su un tratto delle mura urbiche che già in età medievale presentava, più in prossimità di San Sisto, un fornice assimilabile a un passaggio voltato in coincidenza della torre campanaria della chiesa.
Nel XVI secolo, e nello specifico intorno al 1585, reiterati ma destinati a non essere portati a termine, furono i progetti di un ampliamento in chiave monumentale (cospicue le testimonianze documentarie in proposito inserite nelle disposizioni assunte dai Priori conservate presso l’archivio della Biblioteca degli Ardenti).
Nel XVII secolo due furono gli episodi finalizzati a una sua ricostruzione. Tra il 1621 e il 1641 fu convolto a tale progetto lo scalpellino originario di Bagnoregio, Bernardino Parenti, ma i lavori dovettero concludersi soltanto nel 1653 in occasione della visita di papa Innocenzo X Pamphilj in città e a San Martino al Cimino. Come noto, il sopralluogo dell’anziano e ammalato pontefice doveva sancire l’innalzamento ufficiale a principato delle pertinenze territoriali spettanti alla cognata Donna Olimpia Maidalchini. A seguito di tale evento la porta fu ribattezzata come Innocenziana o Pamphiliana, salvo perdere presto nella memoria comune tali denominazioni.
Responsabili di questa fase furono Francesco Majolino (Maiolino), autore del disegno progettuale, e Piero Pieruzzi esecutore materiale. Il francese Monsù Natale eseguì gli stemmi. Non è escluso che a questa serie significativa di interventi abbia collaborato, forse in veste di consulente, anche Giovan Francesco Romanelli. Al 1654 si fa risalire l’esecuzione della statua di Santa Rosa invocata per la conclusione dell’epidemia che devastò la città in quell’anno. Ai lati della scultura campeggiano gli stemmi di Innocenzo X e di Clemente XI. A quest’ultimo è ascrivibile il restauro occorso alla porta nel 1705, ricordato nell’iscrizione.
Con l’esclusiva finalità di ribadire la rilevanza di tale architettura in riferimento alla vita socio-politica cittadina, non sembra ozioso in questa sede ricordare i nomi soltanto di alcuni illustri pacifici “conquistatori” della città che entrarono a Viterbo attraversando Porta Romana: papa Pio II, al secolo Enea Silvio Piccolomini, abituale frequentatore delle fonti termali, l’imperatore Federico III, papa Alessandro VI (Rodrigo Borgia), il cardinale Reginald Pole, il cardinale Alessandro Farnese iuniore. Come di consueto, in concomitanza di tali circostanze, gli accessi pubblici venivano decorati da apparati festivi più o meno sontuosi a seconda delle circostanze. I più ricorrenti prevedevano drappi e luminarie con schieramento di truppe e magistrati ad accogliere l’illustre visitatore.
L’assetto contemporaneo è il risultato degli interventi di messa in sicurezza e restauri occorsi a seguito dei bombardamenti, durante la Seconda Guerra Mondiale, che distrussero una parte cospicua delle mura in prossimità dell’accesso pubblico in direzione di Santa Maria delle Fortezze. (cfr.: A. Scriattoli, 1915-1920 pp. 67-68; G. Signorelli, 1907-1969, III, p. 881, D. Gallavotti Cavallero, 2014, pp. 209-210, con bibliografia precedente).
La mostra architettonica presenta una struttura condotta su tre registri sovrapposti, caratterizzata dall’iconografia celebrativa dell’arco trionfale, inquadrata da un fornice unico a centina semicircolare, inserito all’interno di una cortina bugnata affiancata da colonne tuscaniche semilibere nello spazio a sostegno di una cornice marcapiano che immette al registro superiore dove campeggia l’iscrizione. In corrispondenza delle quote superiori delle mura si innestano gli elementi decorativi del fastigio sommitale sormontato dalla statua che raffigura Santa Rosa. Evidente è il carattere devozionale e apotropaico della scultura posta a protezione di uno degli ingressi principali della città e quindi della stessa Viterbo.
Alla luce dell’attuale stato conservativo l’accesso pubblico si caratterizza per il venir meno dell’intonaco nei sottosquadri e nei setti murari che si alternano alle membrature in peperino. I suoi cornicioni, altresì, offrono spazio sufficiente per specie vegetali infestanti. Nel segno della coerenza con la politica deliberata stagionalmente per Porta Faul, anche in questo caso alcuna forma di rimozione è stata adottata.
A ciò si affianca un dato visivo macroscopico che si evince a seguito di una banale ispezione a distanza, operazione che ogni viterbese che passi in prossimità di questo tratto delle mura urbiche può compiere agevolmente.
Risulta evidente, infatti, come il basamento della scultura della patrona, che reca la dedica “DIVA ROSA”, due degli appoggi a elice degli scudi araldici laterali, i basamenti e i due obelischi posti alle estremità destra e sinistra siano di restauro. Lo denuncia la cromia, il diverso grado di consunzione della superficie lapidea di questi elementi rispetto a tutti gli altri. Tale sostituzione fu compiuta nell’ormai lontano 1990 a seguito di interventi condotti nel corso del decennio precedente. I frammenti originari non furono né recuperati, né restaurati e collocati di nuovo in situ, né tantomeno destinati a forme di musealizzazione, ma incredibile a dirsi, vennero abbandonati in un’area decentrata del parco pubblico cittadino, Prato Giardino.
L’inaccettabile decisione, lesiva dei princìpi di conservazione dei manufatti, fu oggetto di articoli pubblicati sulla stampa locale, in particolar modo dal “Corriere di Viterbo” che dedicò ampio spazio alla vicenda. La polemica sorse grazie alla segnalazione da parte di Alberto Miralli, noto gallerista viterbese, scomparso da qualche anno, che ho avuto il privilegio di raccogliere personalmente e di riferire a suo tempo in una serie di articoli finalizzati a denunciare l’accaduto.
Si potrebbe pensare che, nel corso degli anni, di quegli stessi elementi decorativi si sia persa traccia.
Si potrebbe ipotizzare che siano stati sottratti da quella temporanea e inadatta ubicazione. Forse frazionati e ricollocati come frammenti erratici all’interno del parco? Andati perduti? Rivenduti nel mercato antiquario?
A seguito di un nuovo sopralluogo a Prato Giardino da parte di chi scrive, propedeutico alla redazione del presente testo, è ora possibile rispondere a queste domande: le emergenze architettoniche ascrivibili all’originaria decorazione di Porta Romana si trovano dimenticate, ancora all’interno dello spazio verde, nel più completo stato di abbandono. Si deve rilevare, tuttavia, che tale stato di abbandono si allinea, con inoppugnabile coerenza, alla desolazione in cui versa l’antico barco dei Chigi poi acquistato dal Comune e trasformato in area verde pubblica. Nuove bordure floreali sorgono in mezzo a piazze trafficate, costeggiano le mura, se ne celebrano le aperture, ma il buon vecchio Prato Giardino, ristagna nell’immagine melmosa delle sue vasche, nelle siepi cariate e nei pratini con alopecia.
Ma non divaghiamo.
Accatastate a terra, come rifiuti in una discarica, durante i trentacinque anni trascorsi con esposizione costante alle intemperie e all’incuria, i frammenti della porta versano in condizioni precarie. Visibili le ulteriori ablazioni all’integrità della consistenza lapidea, le lesioni diffuse, la corrosione, l’aggravato stato di degrado. Sul fronte del basamento che sorreggeva la statua è quasi del tutto illeggibile la scritta “DIVA ROSA”. Sono di fatto sfigurati i plinti di supporto degli obelischi e le relative sfere di sostegno, le cuspidi erose dagli anni presentano fessurazioni che hanno ormai compromesso l’integrità delle stesse, già in cattive condizioni quando erano ancora in situ, come documentato dalla catena metallica posta per ovviare alle soluzioni di continuità.
Un aspetto positivo, in chiave naturalistica, in tutta questa vicenda tuttavia sussiste. L’ammasso di pietre dilavate e quasi irriconoscibili nell’antica funzione e struttura costituisce l’habitat ideale per lucertole e ragni, le foglie secche possono cadervi e sovrapporsi indisturbate in strati afferenti alle diverse stagioni, lo stesso le piante spontanee hanno trovato tra i blocchi di peperino luogo ideale per prosperare. Nel clima di rinnovata fortuna delle rovine le superfici testimoniano ancora, secondo un evidente afflato neo-romantico, la presenza di efflorescenze, attacchi fungini e lichenici diffusi afferenti alle annate che si sono susseguite dagli anni Novanta del secolo scorso in poi.
A tutt’oggi devono essere sembrati come lectio difficilior il recupero, il restauro e la collocazione in uno spazio espositivo e, inopinatamente, sì è preferito l’abbandono che tuttora persiste. L’istanza estetica e storica reclamano in tempi rapidi, l’interruzione di questa ingiustificata cecità, di questo disinteresse desolante. Ma a Viterbo, “città d’arte e di cultura”, tutto ciò può accadere, che frammenti lapidei decorativi, evidentemente considerati di scarsa o di alcuna rilevanza, vengano rimossi, con disinvoltura accatastati come rifiuti e quindi di fatto scomparire sotto gli occhi di tutti, nel più assoluto silenzio.
La città attende una risposta alla seguente domanda: fino a quando si dovrà assistere al degrado del patrimonio artistico facendo letteralmente scorrere sulle antiche pietre l’acqua della noncuranza e dell’oblio? Auspicabile che un riscontro significativo giunga prima di altri trentacinque anni.