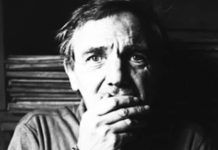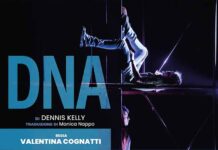L’ultima ipocrisia dello scrolling turistico è legata ai luoghi nascosti: sui social i globtrotter immortalano calette solitarie, specchi d’acqua selvaggi e case diroccate alla luce del tramonto, introducendo una sostanziale novità: al geotag subentra una compiaciuta riluttanza nello svelare il nome e l’esatta posizione del “posto autentico”, che ora merita protezione, rispetto, segretezza. L’ovvio risultato è che dal buco della serratura la percezione del mondo si fa ancora più instagrammabile, sovra esposta, over turistica.
A mezz’ora da Viterbo, non molto lontano dall’inflazionato Canale Monterano, c’è un posto che farebbe gola agli influencer, agli anonimi esteti del pittoresco: si tratta del parco della Mola di Oriolo Romano, decretato Monumento Naturale in virtù dell’Agrostis, una rara specie erbacea che cresce in ambiente sulfureo, motivo che giustifica il coinvolgimento dell’Università Agraria di Oriolo in quanto tenutaria del sito.
A fare gli onori di casa è Paolo Guardalà, oriolese d’adozione e presidente delle associazioni Amici della via Clodia e Monumento Naturale della Mola AST che si occupa in modo impeccabile della manutenzione e della pulizia del sito. “Questo non è un posto da selfie e speriamo che rimanga tale”, spiega con una punta di orgoglio a conferma che stare al di sotto della soglia delle ondate mordi e fuggi è oggi motivo di forza e non di debolezza. A guardarci intorno sembra avere ragione: è un mercoledì di pieno agosto e, ad eccezione di un ragazzo solitario e qualche famiglia, regna la pace. Tutt’intorno una bellezza da cartolina.

A una prima occhiata sono due i punti focali del sito: la sorgente d’acqua sulfurea che alimenta una grande pozza balneabile e l’ex diga che, con la sua cascata, fa di questo tratto del fiume Mignone una piscina a cielo aperto circondata da vegetazione. L’altra attrattiva è il vecchio mulino in via di riqualificazione. “Al suo interno – continua Guardalà – nascerà un’aula didattica. Come associazione siamo attivi nel proporre alle scuole attività outdoor alla scoperta del territorio e delle storie stratificate che ha da raccontarci”.
A tal proposito basta allargare lo sguardo o, come precisa Paolo, fare “escursionismo interpretativo” per capire che dietro la silenziosa suggestione dell’area ci sono i segni (e le ferite) di un passato proto industriale; c’è il disegno feudale dei Santacroce, potente famiglia che fonda Oriolo come borgo ideale e operaio: “Oltre al mulino, costruito a fine Cinquecento e dismesso quattro secoli dopo con l’avvento dell’elettricità, qui c’erano una ferriera, una vetreria, un pullulare di attività di cui oggi rimangono alcune tracce”.
Per giocare a fare un altro lungo salto temporale ci si può avvicinare al cementizio di una villa romana, a pochi metri dall’attuale cascata. Più di ogni altra cosa si può fare qualche passo sul basolato della via Clodia, l’antico tracciato che collegava l’Urbe all’Etruria, e che oggi riemerge dal sentiero in discesa che porta alla Monumento Naturale della Mola. Per una fortunata coincidenza, per una manciata di secondi, i passi dei camminatori di ieri e di oggi si sovrappongono. Ma l’illusione dura un attimo. Gli usi e riusi del paesaggio si mescolano, a volte senza soluzione di continuità. La Mola insegna quanto sia futile la fenomenologia del “ritrovare il fascino senza tempo”: per i romani poteva essere un ninfeo, secoli dopo sarà una diga, oggi è meta di gite domenicali. La speranza è che domani non diventi il luogo nascosto da cui fuggire.