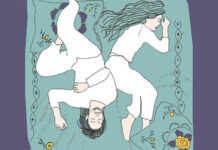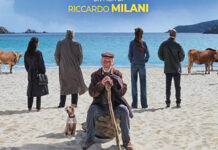“La Città del Sole” presentazione dell’ultimo libro di Salvatore Enrico Anselmi a Palazzo Brugiotti
Lo storico dell’arte e scrittore viterbese Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo romanzo La Città del Sole, Effigi Edizioni (2025), venerdì 16 maggio, alle ore 16.30, presso il Museo della Ceramica, Palazzo Brugiotti – Fondazione Carivit, via Cavour, 67, Viterbo.
L’evento sarà presentato da Luciano Proietti, Presidente di Archeotuscia, associazione promotrice dell’incontro. Dialogheranno con l’autore due noti intellettuali: Luciana Vergaro, docente e saggista, Luciano Dottarelli, filosofo e docente.
Riprese televisive a cura di RTUA – Radio Telediffusioni Umbre Aquesio.
Sinossi
La Città del Sole è un romanzo storico-filosofico, di stampo naturalistico e nel contempo venato di un costante carattere evocativo e visionario. È un romanzo giallo, in ragione dei fatti di sangue che aprono la vicenda e delle relative indagini finalizzate a fare luce su tali episodi. Tuttavia non si esaurisce in questo genere poiché vi si affiancano anche componenti proprie del romanzo di formazione, per quanto attiene la vicenda del giovane Lisandro che attraversa tutta la trama, determinando un’evoluzione significativa e graduale del personaggio in concomitanza con lo svolgimento degli eventi.
La complessa serie di avvenimenti si svolge nel Settecento in una città dell’Italia meridionale mai indicata, né per quanto concerne il nome, né per quanto riguarda la relativa area territoriale. Lo si evince da citazioni, riferimenti, descrizioni paesaggistiche, caratterizzazioni del tessuto architettonico e non ultimo dalla lingua parlata.
Gli abitanti della città bianca usano una sorta di esperanto, di grammelot, generato, talvolta dalla fusione, talvolta dall’accostamento di diversi idiomi territoriali, con la prevalenza del napoletano e del siciliano. La scelta di frantumare l’unità linguistica deriva dall’intento di sottolineare la condizione dei personaggi e del contesto sociale definita dalla perdita di identità culturale come conseguenza dello smarrimento di una dignità umana e comunitaria. Tali circostanze definiscono una dicotomia tra l’aristocrazia e l’alto clero, detentori del potere, e la popolazione per la quale la grande priorità, accanto a quelle primarie di sussistenza, è costituita dal superamento delle condizioni ostative all’affermazione del libero pensiero, critico e civile.
La massa risulta animata nel contempo da istanze di perequazione sociale ma anche da una miscela di superstizione e qualunquismo, di grandezza e miseria, da forme di competizione, da una persistente astenia etica che si confronta con l’arroganza e il formalismo delle classi abbienti.
Incarnano tipologie umane infide e ambigue il vescovo della città bianca, monsignor Torrecremata, e il soprastante alle indagini, Don Argante Palomara. Entrambi costituiscono due declinazioni del male, due distinte affermazioni di una presunzione di superiorità che li pone al di sopra delle norme e li fa agire di conseguenza. Loro antagonista nel corso della storia, e in questo senso il testo è anche un romanzo di formazione, è il giovane Lisandro il quale, aderendo alla congregazione dei Solari, si trova coinvolto, talvolta suo malgrado, in vicissitudini che lo porteranno a compiere atti violenti, ad amare, ma anche a soffrire e auspicare una rivalsa, una redenzione della sua vita. Lisandro uscirà dalla vicenda profondamente cambiato, così come evolute saranno le sue istanze e le sue aspirazioni.
Completa il contesto una serie di personaggi, comprimari e secondari, che contribuiscono a rendere mutevole e sovraffollato l’ambito sociale di riferimento.
Il tenore del romanzo tocca corde sentimentali, tenere e drammatiche, così come tornisce circostanze esilaranti e surreali, secondo un andamento ondivago che talvolta definisce profili fiabeschi.
La Città del Sole è anche una sorta di libro di libri che metabolizza in forma nuova e originale, suggestioni e riferimenti desunti da un’eterogenea e ampia tradizione letteraria rispetto alla quale si colloca in atteggiamento dialettico.
Lo stile è duttile nell’impiego dei registri stilistici e in tal senso si adegua al clima precipuo, oscillando tra eloquio formale e parlata gergale, tra lirico e prosaico. In tal senso il carattere ancipite della forma conserva l’intento di delineare il clima altrettanto ancipite che dilaga nel romanzo per celebrare elevatezza, nobiltà, grandezza di alcuni personaggi che si confrontano con la bassezza pezzente di altri. Ulteriore intento è quello di adeguare variamente la forma linguistica alla tradizione storica settecentesca attraverso un carattere antico e contemporaneo al tempo stesso.