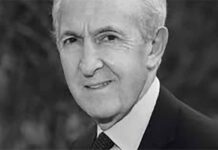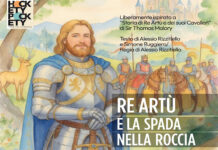La cultura è donna. Il binomio parte dal genere e si estende alle sue caratteristiche: materna e accogliente, la cultura apre le menti, ci fa crescere e capire il nostro posto nel mondo. Allo stesso tempo sa essere agguerrita e armata di intelligenza tagliente e adamantina: si accorge delle distorsioni e rivendica i propri spazi e i propri diritti. D’altra parte, anche la lotta è donna. Nel suo duplice aspetto, Elvira Federici ha dedicato e dedica la sua esistenza alla cultura, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche e soprattutto come principio fondante. Ingegno brillante e multiforme, Elvira è nata a Viterbo e si è laureata in filosofia a La Sapienza. Insegnante di lettere e dirigente scolastica, si è occupata di formazione dei docenti in scuole, associazioni e università. Ha lavorato in Brasile per il Ministero degli Esteri, coordinando e supervisionando la formazione degli insegnanti di italiano brasiliani. Cura per la Biblioteca Consorziale di Viterbo progetti di poesia, filosofia e letteratura. Fa parte della comunità di “Leggendaria”. Ha pubblicato la raccolta poetica “Oriente Domestico” (2005) e una silloge in “Poeti e Poesia” (2017). Dal 2020 è presidente della Società delle Letterate, associazione nazionale impegnata nella valorizzazione e nella diffusione del pensiero e della scrittura delle donne.
Raccontare Elvira è andare a ritroso fino alla sua adolescenza, quando il suo percorso di vita si è intrecciato alle istanze politiche dell’epoca e si è indissolubilmente legato alla cultura. «Credo che tutta la mia vita sia stata effettivamente dedicata a dar vita a iniziative culturali», racconta. «Per dire, alla fine degli anni Settanta io, mio marito, insieme a tutti gli amici e coetanei dell’epoca, costituimmo un’associazione che si chiamava “Gargantua”. Ci eravamo procurati un proiettore cinematografico, io andavo al Goethe Institut di Roma e riportavo in autobus le “pizze” dei film di Mornau, di Fritz Lang… abbiamo poi continuato con il filone della storia artistica della città, con un’associazione che prendeva il nome di Matteo Giovannetti, il grande artista viterbese che affrescò il Palazzo Papale di Avignone. In quel periodo abbiamo creato una sorta di gemellaggio informale con la città francese. Queste esperienze si sono andate spegnendo naturalmente; qualcuno se ne è andato da Viterbo, e la vita ci ha separati». L’esperienza che segna in modo forte il percorso di Elvira è però l’incontro con il femminismo, e le esperienze dei movimenti del post Sessantotto. «Eravamo un gruppo di ragazze che avvertivano una sorta di casella mancante. Quello che veniva insegnato a scuola riguardava solo uomini: pensatori, eroi, combattenti. Ero stata una lettrice precocissima, e anche nella letteratura avvertivo il carattere prevalentemente maschile. Come se, simbolicamente, noi donne non ci fossimo: potevamo solo accogliere, imparare, trasmettere, ma poi dov’eravamo? Erano sempre gli uomini che prendevano la parola. L’incontro con il femminismo è stata per me la cosa decisamente più importante. Proprio perché era un cambiamento epistemologico: invece di vedere il mondo in maniera neutra, astratta, universale, lo vedevo ora abitato da uomini e da donne, esseri vivi e pensanti, ciascuno con la propria esperienza… in questo modo è cambiata anche la prospettiva attraverso cui mi accostavo alla letteratura – ricordo quel sentimento adolescenziale di considerarla come la porta di accesso alla verità – calandola dentro la vita, trasformandola nel racconto di vite vere. Questo sguardo sicuramente mi è venuto dalla pratica del femminismo che è, anche filosoficamente, pensare in presenza, non pensare mai per categorie astratte e neutre, ma sempre a partire dall’esperienza delle vite reali». Negli anni successivi Elvira Federici incontra personalità che segnano ulteriormente il suo pensiero. «Ho avuto modo di frequentare i corsi estivi di semiotica all’Università di Urbino, corsi fortemente voluti da Umberto Eco. Ricordo cene con Eco, con Tullio De Mauro e Silvana Ferreri, con Cesare Segre… È stata una fortuna straordinaria. Nell’esperienza di Urbino, la domanda che continuavo a pormi – sì, ma io dove sto?? – diventò una domanda politica, perché mi trovai tra agguerritissime scienziate e studentesse, e decidemmo di fare un gruppo di lavoro sulle donne e il linguaggio. Il fatto in comunicazione le donne esitassero, il fatto che fossero meno assertive: da dove nasceva questa esitazione? Come renderla occasione di una più vasta riflessione culturale? Anni assolutamente incredibili dove l’esperienza, che io chiamo politica del femminismo, era strettamente intrecciata a quella culturale e intellettuale. Non erano due cose separate».
Federici portò avanti in parallelo anche il suo percorso professionale, che la condusse a diventare prima insegnante e poi dirigente scolastica. «Io nasco come insegnante di lettere, ma dopo pochi anni di ruolo sono diventata preside. Il lavoro da preside è stato un’esperienza impegnativa, e credo di averlo fatto sempre con lo sguardo da insegnante, con l’idea di costruire insieme il sapere e le forme di trasmissione del sapere, all’interno di una comunità». Dopo la parentesi dirigenziale al consolato in Brasile, il ritorno in Italia e poi il pensionamento, che non ha significato il distacco da quanto più ama, anzi. «Ho cominciato a collaborare con “Leggendaria”, una rivista che è una ricchezza immensa. Faccio parte di un grande gruppo redazionale, di cui fanno parte pensatrici, pedagogiste, filosofe, scrittrici, giornaliste. Tutti contesti di pensiero assolutamente stimolanti. La presidenza della Società delle Letterate mi ha molto impegnata in questi due anni e un risultato è stato il frequentatissimo convegno “Ecopoetiche, Ecopolitiche – Poesia come cura del mondo”, reso possibile grazie all’ospitalità della Biblioteca Consorziale. Ma quest’attività, che è a livello nazionale, unita al distacco dal mondo produttivo, mi ha un po’ separato dal contatto con la realtà, dalla dimensione della città, che conto di riprendere». Perché per Elvira è molto importante operare all’interno del luogo in cui vive da tutta la vita. «Viterbo è una città pacata, riservata, e invece io – almeno in una fase della vita – ero ovunque ci fosse movimento, pensiero, discussione, elaborazione… decidere di rimanere in una città così provinciale, in fondo, è stata una scelta di comodità, ma molto ha contato anche il desiderio di elaborare, insieme a questo luogo, tutti i miei desideri di ricerca».
È nata così la fattiva collaborazione con la Biblioteca Consorziale e con Paolo Pelliccia, il commissario che ha reso in pochi anni questa istituzione un luogo moderno e accogliente. «E’ una struttura bellissima che dovrebbe essere più abitata, più frequentata», aggiunge Elvira. Dopo un primo seguitissimo seminario, “Lineamenti teorico-politici di femminismi, genere e differenza”, organizzato in collaborazione con l’Università Roma Tre, Elvira ha collaborato alla realizzazione di incontri-tributo alla memoria del poeta Valentino Zeichen e successivamente alla memoria di Giacomo Leopardi. «Una ventina di incontri, la sala sempre piena, e nessuno che aveva voglia di andarsene… non tantissimi leggono poesia, d’altronde leggere poesia è impegnativo, è “un’aratura del cervello”. Esiste un linguaggio, che non è quello che si appiccica alle cose, ma è quello che le crea. Ne siamo tutti consapevoli in quanto umani, ed è questo ad attrarre, esperti e meno esperti». La grande partecipazione a questi eventi fa riflettere sullo stato della cultura a Viterbo. «È una città dove c’è tanto pensiero, tanta cultura, tanto desiderio, ma è come se non si riuscisse mai a fare incontrare queste cose», conclude Federici. «Chi ha amministrato questa città, non importa di quale parte, è sempre apparso al di sotto dei suoi rappresentati. Non hanno avuto mai la cultura come priorità. E anche chi, come me e altri, tenta di fare qualcosa, non trova l’aggancio, la modalità per dialogare durevolmente. Sono domande che faccio anche a me stessa. Che errori facciamo? Gli eventi che organizziamo riescono certamente a coinvolgere, ma poi finiscono, non è che si alimenti qualche cosa, si origini che possa crescere e proseguire. Bisognerebbe fare un ulteriore sforzo per coinvolgere le persone che poi operino in modo autonomo. Ci sono tante realtà e tanto volontariato, ma anche una frammentazione dovuta all’individualismo che impedisce di fare rete. È una cosa che in una città così piccola si paga molto».