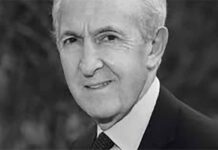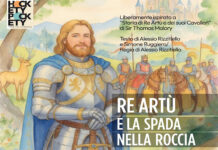La grotta riluce di una luminosità calda e tenue da presepio. Le mani danzano su un blocco informe di materiale rossiccio, il piede colpisce in modo cadenzato la pedana circolare che fa girare il tornio. Le dita esercitano un’attenta pressione sulla morbida argilla rotante, e lentamente appare la forma di un recipiente. La sensualità di un lavoro che coinvolge tutto il corpo, e la sacralità delle mani che riescono a creare dei piccoli capolavori, unite insieme a formare la magia del lavoro del ceramista, un antico mestiere praticato oggi soltanto da pochissimi appassionati, come il vetrallese Angelo Ricci, classe 1985, meglio conosciuto come Checco Lallo. «È un soprannome che proviene da Francesco e Ilario Ricci, due miei antenati che facevano questo mestiere e che in paese erano noti con questi due nomignoli», ci spiega Angelo. «Uniti insieme sono diventati il soprannome della nostra famiglia, come accade ancora nei paesi. Se vieni a Vetralla e chiedi dove sia Angelo Ricci, magari non te lo sanno dire. Ma prova a chiedere dov’è Checco Lallo». I vetrallesi risponderebbero allora che la bottega di Angelo si trova giù in via dei Pilari, una strada che scende accostata al rialzo su cui sorge Vetralla. «Mio padre mi raccontava che queste erano grotte che si erano create con l’estrazione del tufo, con cui si costruivano le case del paese. Gli artigiani ceramisti, i “pilari”, si trasferirono tutti qui, e c’è anche una spiegazione: i laboratori, lungo la via, sono tutti esposti a sud, quindi potevano sfruttare la luce del sole fino al tramonto».
La grotta di Checco Lallo è un vero e proprio museo dell’antica arte, un luogo sospeso dove la storia millenaria si unisce alla tradizione. La sapiente illuminazione enfatizza le schiere di pignatti, brocche, quartaroni, lucerne, piatti, messi pazientemente ad essiccare su scaffali rustici. Sul pavimento sterrato si sfarina ancora polvere di argilla. «Io adesso l’argilla la compro. Ma questa ce la siamo “spicchiata” tutta io e mio zio, con picchio e pala nel bosco», racconta. «Vetralla è un territorio ricco di argilla. E quel declivio che si vede qui di fronte a via dei Pilari si chiama appunto Pian delle Crete». In un territorio così favorevole non poteva non svilupparsi l’antica arte dei “pignattari”; anzi, la figura professionale che più ha rappresentato Vetralla, per lungo tempo, è stata proprio il “pignattaro”, il “cocciaro”, così come venivano chiamati in dialetto. «Piatti, bicchieri, servizi da nozze, boccali per i ristoranti, fino a trent’anni fa venivano a farli qui». Gli artigiani producevano accessori indispensabili per la casa e la cucina, e li andavano a vendere ai mercati della provincia. «Come la grande brocca posizionata al centro del camino nella casa di Santa Rosa, che è la nostra», afferma Angelo. «Checco Lallo vendeva infatti i suoi prodotti al mercato e alla fiera di Viterbo. Sono molti i viterbesi che hanno ancora in casa le sue terrecotte». Gli unici centri nel viterbese che producevano ceramica erano Vasanello, Tuscania e Vetralla. «Vetralla era quella strategicamente messa meglio, perché era la prima che si incontrava venendo da Roma. Gli artisti romani, come Pietro Canonica e Duilio Cambellotti, venivano a cuocere qui nelle nostre fornaci».
I “cocciari” custodivano gelosamente i segreti della loro arte, e usavano contrassegnare i loro manufatti dipingendovi sopra un disegno caratteristico. «Ognuno aveva il suo marchio distintivo, in genere vegetale o floreale. Il nostro marchio di famiglia era ed è tuttora la fogliolina d’ulivo, in giallo e verde. Sono i colori che risaltano maggiormente sul rosso della terracotta. E l’olivo richiama l’essenza stessa del nostro territorio». Un territorio che è permeato dagli antichi echi della storia, che da millenni si riverberano nelle attività artistiche e artigianali dei suoi abitanti. Così nella bottega, accanto a manufatti dalla forma di origine medioevale, trovano posto anche coppe larghe con i manici, ispirate ai kylix greci, e calici, anch’essi con i manici, che omaggiano i kantharos. Linee eleganti che poi i nostri progenitori etruschi hanno fatto proprie, e che Checco Lallo fa rivivere negli anni Duemila.
Angelo ci mostra due vecchie foto in bianco e nero, che fanno bella mostra di sé su una parete. «Questi sono mio nonno Angelo, che non ho mai conosciuto, e il mio prozio Felice. Ho cominciato a frequentare la bottega a dodici, tredici anni, durante le vacanze estive. Mio zio mi ha insegnato i concetti di base, poi ho imparato con l’esperienza». In fondo campeggia l’antica fornace, simile a quella utilizzata dagli antichi Romani, divisa in settori. Il fuoco trovava posto in quello più in basso, e il calore si spandeva all’interno di intercapedini nelle pareti, intorno ai pezzi da cuocere. La cottura è infatti un’operazione molto delicata: i manufatti non devono stare a contatto con il calore vivo altrimenti si rovinano. «Il fumo saliva e scorreva sul soffitto per poi uscire fuori dall’accesso. Ci si regolava con i venti che soffiavano, per evitare di rimanere soffocati. Oggi io uso un forno elettrico, per cuocere la terracotta a 980 gradi. Aspetto un paio di giorni perché i manufatti si raffreddino, piano piano… una volta freddi ci dipingo il disegno e poi passo la “cristallina”, il vetrificante. Così sono pronti per la seconda cottura». È un procedimento lento, che richiede esperienza e buona disposizione mentale. «Il bello di lavorare l’argilla è che quello che hai nella testa, nei pensieri, lo trasporti sulle mani», continua Angelo. «Se sono rilassato lavoro molto meglio, se sono nervoso, mi vengono tutte cose storte, e mi innervosisco ancora di più. È un lavoro che richiede calma e pazienza».
E l’antico tornio a pedale, che campeggia nella bottega, è forse il vero protagonista della scena. «Alcuni artigiani possono usare gli stampi, o la tecnica a colombino. Altri ancora usano il tornio moderno, che è elettrico. Siamo in pochi ad utilizzare il tornio a pedale, tra il Lazio, l’Umbria e la Toscana. A Vetralla siamo rimasti in due, io e mio zio, che a volte mi dà una mano». Già, perché in via dei Pilari è rimasto soltanto Checco Lallo a portare avanti la gloriosa tradizione della terracotta vetrallese. La modernità ha spazzato via l’antica sapienza, insieme a mestieri che un tempo davano il sostentamento a tante famiglie. «La gente apprezza ancora le terrecotte fatte a mano, e magari te le ordina. Ma il mondo è cambiato, siamo abituati ad acquistare una cosa e ad averla subito. Non sono in molti quelli disposti ad aspettare il tempo che ci vuole. Non sono in molti quelli a capire che insieme al pezzo, io vendo tutta la storia che c’è dietro, la tradizione vetrallese vecchia di cinquecento anni». Angelo però nella sua attività ci crede, ed ha provato a renderla la sua occupazione principale. «Una volta diplomato avevo intenzione di riprendere in mano tutta l’attività. Per diversi anni ho cercato di risollevarla, non è andata. L’ultimo tentativo è stato nell’ottobre del 2019, ma poco dopo c’è stata la chiusura forzata per il Covid. Intanto era nato mio figlio, e continuare ad investire su qualcosa, a sostenere le spese, senza nessuna certezza… ho dovuto fare una scelta di campo. Mi sono dedicato ad altro, mantenendola però come passione da esercitare nel tempo libero». Una passione che invece andrebbe incoraggiata e sostenuta, come quella di tutti i ragazzi come Angelo che al giorno d’oggi, malgrado le difficoltà, fanno rivivere arti e mestieri che hanno imparato dai loro nonni. Tramandando in questo modo la nostra cultura e il suo valore inestimabile.
Accanto al tornio, su un riquadro di legno, ci sono dei pezzetti di argilla lavorata, pupazzetti e casette modellati dalla mano di un bambino. Come se si stessero preparando dei futuri Checco Lallo, che portino avanti la tradizione di famiglia. «Li ha fatti mio nipote», sorride Angelo, in attesa di ammirare i lavoretti del figlio, ancora troppo piccolo. Ma di certo la tradizione continuerà, testimoniata dai nomi ricorrenti, che simboleggiano il legame con gli antenati e con la loro antica sapienza. «Ilario era mio padre, Francesco era il fratello. Io sono Angelo, come il nonno… e mio figlio si chiama Ilario».