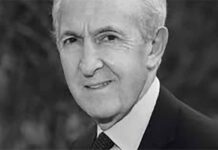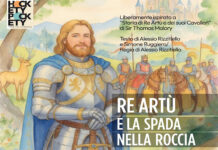Maria Ribeca, giovane e povera, ebbe la fortuna di incontrare a Viterbo nel momento giusto e al posto giusto una benefattrice, tale Lucrezia Lancetta, che le lascò in dote tramite la Confraternita di S. Orsola, la somma di 50 lire per potersi sposare. Lo attesta un documento datato 1907 in mano a Mauro Galeotti, storico e collezionista, che ci rimanda al welfare dei secoli passati.
E ci riporta alla chiesa di Sant’Orsola di Viterbo, in pieno centro storico, che nel XVI sec. cambiò nome e connotati alla preesistente chiesa di San Giovanni in Petra (XII sec.). Fu l’omonima confraternita che, dopo averne preso possesso, provvide alla sua ricostruzione, facendola assurgere a parrocchia e collegiata. La “benemerita” aveva il compito di educare le fanciulle bisognose e da marito. I confratelli vestivano di sacco bianco con mozzetta rossastra ed uno dei loro stendardi, forse il più prezioso, portava la firma del pittore viterbese Domenico Corvi che lo realizzò nel 1775 con l’immagine del Martirio della Santa (nel verso Sant’Orsola in Gloria).
Quest’opera ha avuto una storia travagliata. Venne addirittura sottratta alla sua funzione processionale e trasformata, dopo grossolani ridimensionamenti, in pala d’altare peraltro sistemata addosso ad una parete umida e malmessa dell’attuale chiesa di S. Orsola. Fortunatamente subì intorno al 2008, per iniziativa della competente Soprintendenza, un provvidenziale restauro ed oggi la possiamo ammirare (sia nel recto che nel verso) in una delle stanze di Palazzo dei Priori a Viterbo. In precedenza, nel XVII sec. i fedeli ostentavano uno stendardo più antico eseguito da Francesco Romanelli.
Con la Confraternita alle spalle molte alcune giovani zitelle del posto potevano spesso contare su un lascito per sposarsi. La scelta della fortunata ragazza avveniva di solito secondo il rito tradizionale dell’estrazione a sorte del nome da un bussolo. Va detto che per una fanciulla povera senza una dote era difficile trovare marito.
La chiesa di Sant’Orsola subì nei secoli varie trasformazioni – grazie anche al contributo di generosi benefattori – e oggi l’ammiriamo nelle fattezze risalenti del XVIII sec. Sull’attuale facciata leggiamo Templum Ven. Societatis S. Ursulae. Dopo il Concilio di Trento il titolo di Collegiata venne revocato, date anche le scarse rendite. Alla fine del Cinquecento perse anche quello di parrocchia a favore delle vicine San Leonardo e San Pellegrino, con i beni assegnati alla chiesa di Santa Maria Nuova.
Orsola, martirizzata nel IV sec. d.C. è legata alle vicende leggendarie di un matrimonio combinato con un principe pagano e al viaggio con undicimila vergini che furono trucidate dagli Unni. Viene considerata la patrona della gioventù femminile, ma anche delle maestre e la sua figura è anche associata alla “Compagnia delle dimesse di Sant’Orsola” fondata a Brescia nel 1535 da Angela Merici. Una lapide a lei dedicata presso la chiesa di Colonia in Germania ne ricorda le virtù.
Oggi la chiesa è stata di nuovo restaurata dopo anni di abbandono e quanto prima verrà restituita alla comunità locale per attività sociali e culturali. L’interno si presenta ad aula e propone uno spazio adeguato a conferenze, mostre e concerti. Dei vecchi arredi non rimane più nulla, se non un ovale (tempera su tavola) di Domenico Corvi (1749) raffigurante San Giovanni Evangelista, oggi custodito nel Museo del Colle del Duomo di Viterbo Si trovava sull’altare di destra come sottoquadro di un dipinto raffigurante Santa Lucia restaurato dallo stesso Corvi.
La chiesa disponeva di varie opere d’arte (dipinti e corredi liturgici) che sono andate distrutte o trasferite in altre sedi. Oltre alla tela-stendardo dell’altare maggiore, si ricordano una sulla Madonna Immacolata andata dispersa come quella di Santa Lucia. Secondo un documento citato da Galeotti, nel 1941, era accertata la presenza di tre campane di varie epoche, una delle quali risalente al XV sec.
Negli ultimi decenni, la chiesa è stata utilizzata come aurtorimessa, magazzino comunale e falegnameria. Fu anche la sede momentanea dell’associazione “Il Frisigello” il cui nome ci rimanda alla leggenda delle sei nobiltà di Viterbo. Mito e tradizioni ci informano che questo singolare personaggio, maschera del carnevale viterbese di molti secoli fa, “faceva giochi meravigliosi che non trovavano pari”. Si deve all’associazione legata al suo nome se per alcuni anni la chiesa ha potuto conservare alcuni elementi di Macchine di Santa Rosa degli anni passati.
L’autore*
Console di Viterbo del Touring Club Italiano. Direttore per oltre trent’anni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Viterbo (poi Apt). È autore di varie monografie sul turismo e di articoli per riviste e quotidiani. Collabora con organismi e associazioni per iniziative promo-culturali. Un grande conoscitore della Tuscia.