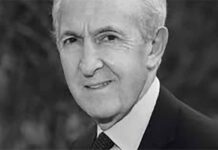Avvenimenti, fatti e personaggi – noti e meno noti – della storia della Tuscia e raccontati da un punto di vista non conformista.
TANTO PE’ CANTA’
Ettore Petrolini (genitori originari di Ronciglione) verrà raccontato dal pronipote Franco in uno dei prossimi appuntamenti del Touring Club di Viterbo. Ben noto cabarettista (ma non solo), ha scritto nel 1932 la musica di Tanto pe’ cantà” , la celebre canzone su testo di Alberto Simeoni. Dopo la sua morte nel 1936, la composizione venne accantonata e cadde nel dimenticatoio. Ci pensarono Luigi Magni, super regista-sceneggiatore di indimenticabili filmati in romanesco, e Franco Petrolini a riproporla al pubblico invitando Nino Manfredi a rilanciarla. Fu lui a inciderla per il Festival di Sanremo 1970. Godiamoci la prima strofa:
È una canzone senza titolo
Tanto pe’ cantà
Pe’ fa quarche cosa
Non è gnente de straordinario
È robba der paese nostro
Che se po’ cantà pure senza voce
Basta ‘a salute
Quanno c’è ‘a salute c’è tutto
Basta ‘a salute e un par de scarpe nove
Poi girà tutto er monno
E m’a accompagno da me
INVASIONE DI FRATI AL PARADISO
Durante l’Anno Santo del 1600 (pontefice Clemente VIII, alias Ippolito Aldobrandini) si registrò a Viterbo un “gran concorso di frati” che misero a dura prova le scorte del convento di Santa Maria del Paradiso (allora presidio dei Minori Francescani), tanto che il Comune fu costretto ad intervenire con un’elemosina di trenta scudi. Quel Giubileo registrò a Roma l’arrivo di mezzo milione di pellegrini. Tra questi, i rappresentanti di tutte le Confraternite di Viterbo (una ventina). Gonfalone, San Clemente, Disciplinati, Misericordia, San Rocco, San Leonardo, Morte, Cella, Suffragio, Sant’Egidio, Sant’Orsola, SS. Sacramento, Sacchi ed altre. Ammende e torture per osti e albergatori disonesti. In quell’anno, il 17 Febbraio a Campo dei Fiori a Roma venne bruciato vivo come eretico Giordano Bruno.
PAOLO RUFFINI
Nato a Valentano, nell’alto Viterbese, nel 1765, ma ben presto lasciò il paese natìo per trasferirsi a Modena dove rimase fino alla morte nel 1822 .Matematico e medico, fu il primo assertore della irresolubilità con radicali delle equazioni generali di grado superiore al quarto ed è ben noto per la sua famosa regola della divisione dei polinomi. A Viterbo gli hanno intestato il Liceo Scientifico che attualmente è sistemato negli ambienti dell’ex monastero domenicano di Santa Caterina dove alloggiò Vittoria Colonna nella prima metà del Cinquecento. L’aula magna del Liceo occupa lo spazio della chiesa del monastero (dedicato a Santa Caterina d’Alessandria) che venne affrescata nel 1712 da Antonio Colli con la scenografica “fiction barocca” del soffitto.
DONNE DEL CONGO VISTE DA BRUGIOTTI
“Il marito può giacere con la schiava purché sia di buona salute e non malata, nel qual caso va su tutte le furie…. Le donne sono migliori e differenti di quelle europee; se vengono a conoscenza di un segreto o di una tresca, sanno tenere la bocca chiusa e non valgono scudisciate o doni a farle parlare. ..” Le annotazioni sono di un frate di Vetralla (poco distante da Viterbo), tale Giacinto Brugiotti, missionario nel Congo intorno alla metà del Seicento. A lui si devono, tra l’altro, lo studio della lingua congolese e la stesura di una relazione socio-geografica della zona che a quel tempo non conobbe l’eguale e che ancora oggi fa testo.
LA SECCHIA RAPITA E STAMPATA
Ricordate la “Secchia” di Modena ? Sta esposta nel palazzo comunale di piazza Grande di quella città. Venne rubata ai bolognesi in una delle tante battaglie nel 1325. Alessandro Tassoni nel 1614 ne fece una cantica eroico-comica dal titolo “La secchia rapita” la cui prima edizione italiana, dopo quella di Parigi del 1622, venne stampata a Ronciglione nel 1624. La cittadina del Viterbese dal XV al XVIII sec. godeva infatti di una certo prestigio come centro tipografico. Vi si stampavano carte da gioco, opere e spartiti musicali.
TOMBA COL PAPA’ DI NAPOLEONE
Si trova nella Collegiata settecentesca di Canino dedicata ai Santi Apostoli Giovanni e Andrea, precisamente nella Cappella che custodisce i monumenti funebri di Carlo Bonaparte (padre di Napoleone e Luciano), Cristina Boyer (prima moglie di Luciano), Giuseppe Bonaparte (figlio di Luciano morto all’età di 14 mesi) e di Luciano Bonaparte (fratello di Napoleone) rappresentato sul letto di morte accanto alla moglie. Le opere, in marmo di Seravezza, portano la firma del Laboureur e del Pampaloni.
L’Autore*
Console di Viterbo del Touring Club Italiano. Direttore per oltre trent’anni dell’Ente Provinciale per il Turismo di Viterbo (poi Apt). È autore di varie monografie sul turismo e di articoli per riviste e quotidiani. Collabora con organismi e associazioni per iniziative promo-culturali. Un grande conoscitore della Tuscia.