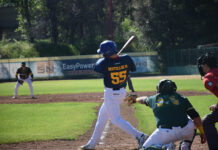Per I racconti del giovedì la terza puntata de Le case della Vita. Maria Letizia Casciani ci accompagna nei momenti felici dell’infanzia tra i trucioli di legno, le paure quando si varcano porte sconosciute e il pericolo che ti aspetta al di là del muro.…. Buona lettura
Il babbo ha fatto il falegname per tutta la vita. La mamma, per un lungo periodo, fino agli inizi degli anni Settanta, ha gestito un negozio di ferramenta.
La bottega del babbo e quella della mamma erano a pochi metri di distanza l’una dall’altra, perché la ferramenta era situata all’interno della vasta area che ospitava la falegnameria e la casa dei nonni paterni, oltre ad un grande orto nella parte retrostante gli edifici.
Noi bambini – specie d’estate – trascorrevamo molto tempo lì a giocare, tra tronchi di legno accatastati, macchine da falegnameria, mucchi di materiali dei tipi più diversi.
Uno dei nostri passatempi preferiti era quello di arrampicarci sulle cataste di grossi tronchi ancora da lavorare e messi lì a stagionare, per andare a caccia di formiche giganti.
Io e mia sorella ci armavamo di cacciaviti ed incidevamo profondamente la superficie del legno, fino ad arrivare nel punto più profondo e nascosto dei nidi delle formiche. Ci incantava il momento in cui arrivavamo nell’ambiente dove erano custodite le pupe degli insetti, di un colore bianco pallido e totalmente trasparenti.
A volte trovavamo anche le uova, senza curarci troppo degli attacchi delle operaie che difendevano disperatamente il nido dal nostro attacco.
Ci piaceva moltissimo restare in equilibrio su quei tronchi così grandi e farli oscillare, per mettere alla prova il nostro senso di equilibrio.
Oggi a nessuna persona dotata di buonsenso verrebbe in mente di lasciare a zonzo bambini piccoli in un luogo così pieno di pericoli, molti dei quali potenzialmente mortali, ma allora funzionava così, non si badava troppo a rischi come quelli, che oggi farebbero rizzare i capelli dallo spavento anche al genitore più lassista.
Nella ferramenta della mamma si poteva trovare ogni tipo di chiodi, da quello grande da cantiere, fino a quello sottilissimo, senza testa. Erano tutti collocati, in bell’ordine, all’interno di cassettini di legno grigi, posti davanti ad una bilancia, che serviva per pesarli al momento della vendita.
Quando passavo i pomeriggi a bottega, avevo l’abitudine di portare con me manciate di chiodi, che poi ritrovavo regolarmente nelle tasche, una volta tornata a casa. Piantare chiodi era un gran bel passatempo.
Nella ferramenta c’erano anche le viti, da quelle in ottone a quelle più scure, in bronzo.
Oltre a piantare chiodi, infatti, un altro dei miei passatempi era quello di riuscire a far entrare nel legno le viti, armeggiando con il cacciavite.
Insieme a chiodi e viti, nella bottega della mamma c’erano attrezzi di ogni tipo: cacciaviti, pinze, tenaglie e poi barattoli di vernice, di acquaragia, olio di lino, tutto concentrato in pochi metri.
Un paradiso, anche per le bambine!
La cosa bella era che nella ferramenta della mamma c’erano quasi gli stessi materiali che si potevano trovare nella bottega del babbo, anche quello un luogo pieno di pericoli, ma carico di divertimenti per noi.
Appena si entrava in quella sorta di capannone gigantesco che era la falegnameria, c’era la grande sala delle macchine piallatrici, delle seghe a nastro, tutte molto pericolose: avevamo il divieto assoluto di avvicinarci e di toccare, soprattutto di spingere i tasti di accensione.
Potevamo toccare la segatura, i trucioli di legno, che noi chiamavamo “riccetti”, ed i piccoli pezzi di tavola avanzati dalla lavorazione, che utilizzavamo come se fossero stati dei mattoncini.
Usando martelli, colla, chiodi, li mettevamo insieme, formando strani pupazzi, casette e tutto quello che ci veniva in mente. Trascorrevamo ore e ore così, ad assemblare quei materiali.
A dieci anni ero in grado di maneggiare il martello con grande destrezza, a tal punto che una volta, durante una gita scolastica al Luna Park dell’Eur a Roma, vinsi un bel po’ di premi nello stand in cui si doveva riuscire a piantare un chiodo con solo tre colpi, assestati con una sola mano. Per me era il pane quotidiano!
Dopo che ebbi vinto diversi premi, ad un certo punto il gestore mi impedì di continuare a giocare, perché capì di avere di fronte una professionista del martello, che gli avrebbe presto prosciugato il magazzino.
Dall’altra parte della falegnameria, in un locale più piccolo, si trovavano i banconi sui quali il babbo portava a termine il lavoro iniziato nella sala dei macchinari.
Per arrivare in questo locale bisognava attraversare un corridoio piuttosto stretto e buio, ai lati del quale erano disposte, su degli scaffali in metallo, delle bare di legno.
Quel breve corridoio era tremendamente sinistro e ricordo bene l’angoscia che mi creava il fatto di doverlo percorrere da sola. Stare in compagnia, però, a volte non giovava, perché io e mia sorella a volte giocavamo a spingerci verso le bare, per vedere chi delle due riusciva ad essere più coraggiosa, col risultato che quasi sempre entrambe scappavamo via gridando, terrorizzate.
A quei tempi, nei paesi come il nostro, era il falegname ad occuparsi anche delle pompe funebri e non era per niente strano vedere delle bare in una bottega come la nostra, dato che si doveva essere pronti in qualsiasi momento.
Sui banconi di quel laboratorio la nostra passione erano le lime, i morsetti, il grande barattolo del Vinavil, la colla, con cui noi ricoprivamo le dita e il palmo della mano.
Una volta seccata, tiravamo via con delicatezza quella pellicola, che rivelava, con grande nettezza di particolari, le nostre impronte digitali. Una meraviglia.
I banconi da lavoro della falegnameria erano per noi irresistibili. Mia sorella ed io trascorrevamo in quella stanza molto tempo. Spesso osservavamo il lavoro del babbo, seguivamo i suoi gesti, così sicuri e carichi di manualità. Lo guardavamo mentre piantava i chiodi con grande sicurezza, disponendoli in una lunga fila ordinata; altre volte verniciava o incollava insieme due pezzi, fermandoli poi con dei morsetti.
A me piaceva guardarlo mentre usava la pialla a mano, per lisciare una superficie: il ricciolo di legno che ne usciva si arrotolava su se stesso. A me piaceva raccoglierlo ed osservarlo, sul palmo della mano.
Intorno a noi aleggiavano gli odori tipici di quel luogo: legno, colla, vernice. Ancora oggi, dovunque mi trovi, riesco a riconoscere la presenza di una falegnameria nei dintorni attraverso quegli odori per me così familiari, rassicuranti, quasi fossero gli odori di una casa. Sono odori che sanno di infanzia.
Una delle pareti del laboratorio era quasi tutta a vetri. C’era una grande porta che dava direttamente sull’orto. Per terra, per un raggio di sette-otto metri, un tappeto di vetri. Ogni pezzo avanzato dalle lavorazioni veniva lanciato lì e poi si frammentava col via vai quotidiano. Le scarpe del falegname erano pesanti e non venivano certo intaccate da quel tappeto così insidioso.
Un pomeriggio, inseguita da mia sorella, mi sono precipitata fuori da quella porta. Ero scalza. Mi sono trovata al centro di quel tappeto di frammenti ed ho cominciato a gridare, senza nemmeno poter fuggire di lì. Per giorni e giorni non ho potuto né camminare, né fare il bagno al lago, con mio grande dolore. Ricordo ancora oggi il dolore lancinante provocato dal vetro che entrava nella carne viva dei miei piccoli piedi.
Per chi non avesse letto la seconda puntata clicca qui
La prossima puntata giovedì 25 aprile