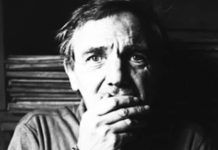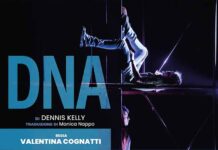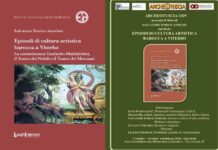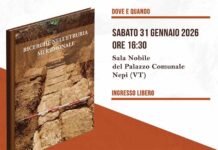“Gino Aldi Mai. Il Candidato agrario, Tra il Biennio rosso e l’avvento del Fascismo nella Maremma e nella Tuscia, 1919-1924”, scritto da Franco Dominici e Silvio Antonini e pubblicato nella collana Archivi riemersi da Effigi, è un libro snello e lineare, di scrittura tersa e dunque assai agile alla lettura (a tratti, in qualche modo, anche avvincente). Ma pure puntiglioso – ineccepibile sotto il profilo documentario, con riferimenti continui a una vera messe di carte d’archivio e stampa d’epoca, locale e nazionale; nonché denso di implicazioni metodologiche (si legga in quest’ottica l’ottima Prefazione firmata da Antonini alle pp. 7-14). Un volume utilissimo, e vorrei dire prezioso, sia per lo storico di professione che per il lettore non addetto ai lavori. Vediamo perché.
Intanto, l’esauriente Quadro di contesto socioeconomico e politico relativo al primo dopoguerra in Maremma (ben tratteggiato da Dominici) prepara il terreno per un corretto approccio critico alle ragioni profonde e alle modalità concrete del dilagare dello squadrismo paramilitare in camicia nera. Va ribadito una volta di più: come un feroce rimedio omeopatico, la violenza fascista fu più intransigente (con tratti orribili) laddove più forte era stata la recente avanzata politica e sindacale delle masse popolari: specie perciò in Emilia Romagna e in Toscana. In Maremma poi, dove anarchia e socialismo si erano capillarmente diffusi, con vasti e radicati consensi in comunità locali caratterizzate da una endemica povertà di secoli, tale violenza si fece, non di rado, letteralmente carneficina. Si raccomanda a questo proposito, alle pp. 107-114, il drammatico paragrafo dedicato alla strage di Roccastrada: esso sa restituirci l’ambiguo intreccio di fattori e tensioni da cui la catastrofe fu innescata, precipitando sulla popolazione locale con tratti da tragedia greca, ma anche con la grottesca aggravante da farsa per le reali cause della morte dello squadrista Ivo Saletti, accertabili e accertate solo con la caduta del regime.
A seguire, con il capitolo secondo, dedicato all’alba della reazione agraria in Maremma e alla sua organizzazione, si entra nel vivo della trattazione. Dominici vi profila con assoluta nettezza il ritratto (figura e carriera) del candidato politico dell’Agraria maremmana Aldi Mai come specimeno disvelante di una più ampia casistica nazionale: l’ambiguità della classe possidente terriera, dalle radici fragilmente liberali (economicamente schiavista), la quale, deliberatamente sottovalutando i rischi di una deriva illiberale per il Paese tutto (come poi si sarebbe di fatto verificato), preferì lasciarsi sedurre per sciagurato opportunismo dal violento vitalismo squadrista, riconoscendo in esso il più affidabile strumento per arginare -reprimere l’avanzata delle masse, e cancellare così i diritti conquistati sul lavoro (patti mezzadrili eccetera). Nei latifondi come nelle miniere, nelle località portuali come nelle fonderie.
Sembra infine una tragica mappa del Risiko la dettagliatissima (e assai eloquente) cartografia della strategia di penetrazione fascista nella “rossa” Maremma durante il cosiddetto Biennio nero (1921-22) accuratamente stilata da Dominici nel capitolo terzo (Maremma in fez). Ci sono i paesi a nord del Grossetano, liminari al livornese e al Volterrano, come Monterotondo Marittimo e Tatti, Massa Marittima e Ribolla; ma anche le cittadine del tufo, ai confini con l’allora provincia romana, come Sorano e Pitigliano (a Sorano, ma pure al caso di Manciano sono dedicati corposi paragrafi ad hoc, alle pp. 54-82 e 138-157); ci sono i centri esposti verso Siena, come quelli sul versante grossetano dell’Amiata e, ovviamente, la nevralgica Roccastrada; e poi la costa, con Orbetello e l’Argentario, Follonica e Grosseto. Per il capoluogo e per Orbetello (pp. 98-107), Dominici parla, con sintomatico lessico bellicista (degno di un assedio medievale), di una conquista fascista: sempre evidenziando però “distrazioni” e favoreggiamenti, complicità e partigianerie da parte delle forze dell’ordine e di uomini delle istituzioni (situazioni ormai abbondantemente confermate da cospicua tradizione storiografica nazionale), quasi sempre, tranne qualche raro lodevole caso, spudoratamente a vantaggio della violenza paramilitare fascista. Saturando velocemente il territorio provinciale (ma forse neanche troppo), le gite di propaganda (questo l’osceno eufemismo riservato dalla pubblicistica fascista alle violentissime incursioni dei cosiddetti camionisti) piazzano ovunque le bandierine di una barbarica strategia del terrore tutta concentrata contro le comunità locali: sistematica devastazione delle strutture organizzative e solidaristiche popolari, sequestri di persona, brutali pestaggi, sevizie, efferati omicidi a freddo. Tutto per ottenere lo smantellamento della rete organizzativa proletaria e le dimissioni forzate da parte delle amministrazioni civiche, per lo più di sinistra. Mi piange il cuore al solo dirlo, ma in questo libro il lettore s’imbatterà in casi di cadaveri di militanti decollati, di cleptomania sistematica su corpi martoriati, di ferite inflitte da mazze ferrate e crani fracassati, di impietosi aborti procurati per terrore e minaccia.
Interessante, e lungimirante per prospettive di metodo, l’espansione geografica dell’indagine verso l’Alto Lazio viterbese realizzata con il capitolo quarto, a cura di Antonini (pp. 159-180), dedicato al costernante delitto di Torindo Zannoni (consumatosi in Acquapendente il primo maggio 1922) e certi riflessi del delitto Matteotti nella Tuscia (che ci ricordano come l’ondata delle violenze squadriste si prolungasse ben oltre la marcia su Roma, fino al tempo della cosiddetta normalizzazione). Il caso aquesiano risulta particolarmente significativo. Da una parte infatti, esso ci ricorda che l’Italia era (ed è, ancora oggi) il paese dei cento campanili, mosaico composto da un brusio di identità locali separate da netti confini dialettali, ma anche da continuità storico-culturali che travalicano e attraversano, relativizzandoli, i nudi confini amministrativi. Dall’altra, che lo squadrismo operò trasversalmente, imperversando proprio per aree contigue e culturalmente omogenee: Acquapendente si trova, non a caso, a un nevralgico crocevia tra Lazio, Umbria e Toscana meridionale, sulla strada maremmana tra Orvieto, monte Amiata, i paesi del tufo, Manciano e Magliano, la costa tirrenica.
Fecondo l’incrocio della cartografia qui sommariamente ripercorsa con la cronologia ragionata della Fondazione Fasci di combattimento in provincia di Grosseto (pp. 181-190): attraverso date e località, esso ci racconta le molte resistenze, difficoltà e discontinuità di penetrazione incontrate in Maremma dall’avvento del fascismo. A sigillo del volume una ricca Bibliografia, che batte a tappeto la pubblicistica e la storiografia locali ma anche classici del genere come Angelo Tasca, e manovrando con cura l’agiografia di parte fascista (Chiurco, per esempio), e un suggestivo Album fotografico che meriterebbe analisi a parte.
In chiusura, il maggior pregio di questo studio, mi sembra la capacità di restituire, attraverso un’indagine storiografica di ambito locale ma di respiro nazionale, una vera e propria “etnografia”, fattuale e simbolica, della violenza fascista (dalle canizze tribali che si consumavano a ogni inaugurazione di gagliardetto, alla sistematica venuta da fuori delle squadre con l’impiego di militanti locali in funzione di veri e propri scout del terrore), degna di quella Psicologia delle masse e analisi dell’Io che Freud pubblicava proprio nel 1921. Esemplare e ricapitolativa, in tal senso, la lunga citazione di Giacomo Matteotti tratta dal Discorso tenuto alla Camera dei deputati il 10 marzo 1921 e posta dagli autori in esergo al libro (p. 15).