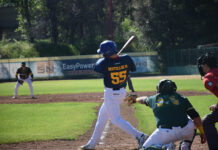Ieri era la peste, oggi è il Coronavirus. Ieri era epidemia, oggi è pandemia, come conseguenza fisiologica della globalizzazione. Nemici, vecchi e nuovi, difficili, praticamente impossibili da fronteggiare. L’unica vera, primitiva arma a disposizione era e resta il distanziamento sociale. Un protocollo del 1542, stilato dal notaio viterbese Bernardino Latini, sta a testimoniare che in quell’anno la città (e il suo circondario) fu colpita da una delle periodiche ondate di peste ed elenca, attraverso un pubblico documento, quali furono le misure adottate per far fronte all’emergenza. Primo, inevitabile provvedimento, la chiusura di tutte le porte che si aprivano lungo le mura, tranne quelle secondarie di Valle, nei pressi di Faul, e quella di San Matteo, ora della Verità. Rispettivamente a Ovest e a Est di Viterbo. Era proibito a chiunque entrare senza aver prima dimostrato di essere stato almeno per un mese lontano da “lochi non suspecti”. Cioè doveva essere accertata la provenienza. Ermeticamente chiuse anche le osterie all’esterno della cinta muraria, con sole due eccezioni, la locanda della Montagna di Mastro Fardo, situata lungo la via Cimina e quella detta della Porchetta, a due chilometri dalla città sulla Cassia Nord. I gestori dei due “ostelli” erano però tenuti a rispettare alcune inderogabili regole. Il protocollo notarile spiega con dovizia di particolari una di esse: le locande dovevano essere adeguatamente fornite per ospitare, notte e giorno, cavalieri e pedoni e i gestori non potevano avvicinarsi alle due porte ancora aperte della città se non uno alla volta portando con sé “un fazzoletto o pannicello in spalla”, come segno di riconoscimento. Comunque era loro vietato l’ingresso: la lista della spesa giornaliera veniva passata ai vigilanti e gli approvvigionamenti recapitati poi all’esterno. Insomma, nessun contatto diretto tra residenti e chi veniva da fuori, tranne che per un necessario “brevi manu”. Trasgredire le norme poteva costare multe salate e almeno “due tratti di corda”. E poi altre regole assolutamente rigide. Vietato ospitare in casa o in osteria “alcuno forestiero”. Serrate ermeticamente le porte di chiese e conventi oltre le mura per scongiurare possibili intrusioni. Chi era fuori città, fuori città doveva restare. Un divieto esteso anche a chi viveva al di là delle mura, oggi si direbbe in periferia, tanto è vero che in questo caso i rifornimenti quotidiani potevano avvenire soltanto all’esterno delle due porte rimaste aperte. Immaginabili le file e anche le inevitabili discussioni sotto quella di Valle e di San Matteo. Situazioni registrate anche in tempi recentissimi. Nonostante le precauzioni, sopravvivere alla peste risultava quasi sempre conseguenza del caso: la falce della morte mieteva vittime a ritmi crescenti. Chi si ammalava e non aveva né casa né famiglia veniva trasportato all’ospedale di San Sisto, poco distante da Porta Romana o in un’altra dimora, comunque isolata. Se la peste colpiva in casa, allora scattava la quarantena per tutta la famiglia e soltanto uno dei componenti aveva la possibilità di uscire ma unicamente per….fare la spesa. A carico del Comune operavano due “maestri”, uno “phisico” e un “cerusico”, praticamente un medico generico e un chirurgo. Quattrocento i necrofori mobilitati e già il loro numero sta a dimostrare la virulenza dell’epidemia. I “forestieri”venivano sepolti nel cimitero di Santo Spirito, presso l’odierna chiesa di Santa Croce, nella valle di Faul. Il protocollo sanitario conteneva anche misure nei confronti dei pellegrini e degli individui ritenuti non esattamente di specchiata integrità morale. I primi potevano raccogliere il poco necessario per sopravvivere, frutto di elemosine, presso la chiesa all’inizio della strada Cimina o alla Croce, lungo la Cassia/Francigena, direzione Montefiascone. “Furfanti e altri forestieri inutili”, invece, venivano immediatamente espulsi da Viterbo. Senza se e senza ma. La peste, narrano le cronache del tempo, ebbe il picco dei contagi in estate, tanto è vero che i Priori furono costretti a sfrattare i frati francescani del convento di Santa Maria della Ginestra (oggi di San Giovanni Decollato), sotto la Trinità, per allestirvi un improvvisato lazzaretto. Impossibile quantificare il numero delle vittime: la peste non ne ha mai tenuto conto, figurarsi cinque secoli fa.
Foto. Ex Chiesa di Santa Croce archivio fotografico Mauro Galeotti