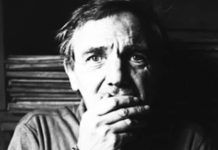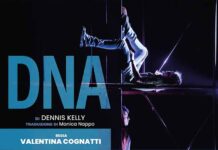Il Cattivo Poeta è il film che racconta con efficacia la storia degli ultimi anni di vita del poeta Gabriele d’Annunzio e dell’Italia stessa, un istante prima che precipiti nel baratro della guerra.Da cui l’autore dell’articolo trae spunto consegnandoci il suo saggio riflessivo.
“Nel film The Killing Fields (Urla del silenzio, 1984), che racconta il genocidio perpetrato dalla dittatura dei Khmer rossi in Cambogia, si afferma con inquietante chiarezza: “La delazione è il primo dovere del Khmer rosso.”
Questa frase racchiude l’essenza più spietata e disumanizzante di ogni regime totalitario: la trasformazione del cittadino in spia, la distruzione dei legami familiari e la sostituzione della coscienza con l’obbedienza cieca.
I Khmer rossi, ossessionati dalla purezza ideologica, cercavano una sorta di “verginità rivoluzionaria”, eliminando chiunque fosse entrato in contatto con il passato. In questo contesto, l’infanzia diventava uno strumento di potere: i bambini, considerati incontaminati, venivano separati dalle famiglie, rieducati e poi utilizzati come strumenti di controllo e terrore. La delazione non era solo un atto di obbedienza, ma un rituale di appartenenza al nuovo ordine.
Quel folle esperimento politico e umano finì solo grazie all’intervento del Vietnam, ma i suoi effetti devastanti rimasero a lungo impressi nella memoria collettiva.
Perché queste riflessioni oggi?
Ieri sera ho rivisto Il cattivo poeta (2020), film che racconta l’ultimo periodo di vita di Gabriele D’Annunzio, in particolare il suo rapporto difficile e critico con il regime fascista, soprattutto in merito all’alleanza con Hitler. Il Vate, ormai isolato nel Vittoriale, si oppose apertamente a quel patto scellerato, intuendone le conseguenze. Non fu il solo: anche figure come Galeazzo Ciano e Italo Balbo sembrerebbe avessero manifestato dissenso.
In quel periodo di allineamento forzato, la poesia satirica restava uno dei pochi strumenti per dire l’indicibile. Lo stesso Trilussa, con amara ironia, commentò la visita di Hitler a Roma scrivendo:
“Roma de marmo rifatta de cartone,
pe’ fa’ festa a un imbianchino,
suo prossimo padrone.”
Un verso che, con poche parole, denunciava la mistificazione e l’umiliazione di una città intera piegata alla propaganda. (Alcune aree degradate di Roma erano state nascoste con cartoni dipinti per simulare facciate curate e strade ordinate ed uno dei mestieri di Hitler era stato fare l’imbianchino, in gioventù.)
Ma ciò che mi ha colpito di più nel film è una scena apparentemente intima, ma straordinariamente rivelatrice. Il giovane federale, sempre più turbato dalla realtà che sta scoprendo, torna a casa. Il padre, fedele al regime, lo accoglie e gli riferisce che un amico di famiglia aveva pronunciato una frase minacciosa contro il Duce. Il figlio, con un filo di delusione e compassione, risponde:
“Ma babbo, sono tanti anni che lo conosciamo…”
E ancora, in un altro momento, quando il padre versa il vino e una goccia cade su un’immagine del Duce, reagisce con spavento, temendo ripercussioni. Il figlio lo rassicura, ormai consapevole:
“Babbo, stai tranquillo… sono io.”
Quella breve scena dice molto: racconta la paura interiorizzata, la sorveglianza interiorizzata, la distanza tra generazioni, tra chi è cresciuto dentro il culto del capo e chi sta cercando di uscirne. E soprattutto racconta la fragilità della fiducia, in un tempo in cui un figlio poteva essere un delatore del padre, o viceversa.
La delazione è il volto più meschino del potere autoritario: trasforma l’intimità in pericolo, l’amicizia in sospetto, la parola in arma. È la negazione della comunità, della fiducia e della libertà interiore.
Che si tratti della Cambogia di Pol Pot, della Germania nazista, della Russia stalinista o dell’Italia fascista, il principio è sempre lo stesso: chi controlla la parola e la denuncia, controlla le coscienze.
Ma questo meccanismo può riaffiorare anche in contesti democratici, in momenti eccezionali. Durante la pandemia di COVID-19, anche in società libere, abbiamo assistito a una riemersione del controllo sociale rivelato nel delicato equilibrio tra libertà individuale e responsabilità collettiva. In nome della sicurezza, si è talvolta sacrificata la comprensione e la fiducia.
E quando la fiducia viene meno, la società comincia a somigliare a quei regimi che credevamo lontani.
Ecco perché riflettere su questi temi oggi non è un esercizio accademico, ma un atto di vigilanza democratica.
La storia ci insegna che la delazione prospera là dove il pensiero critico muore, dove il dissenso è punito, dove la paura prende il posto del dialogo e soprattutto dove la Coscienza smette di interrogarsi…”
Per un confronto con l’autore: