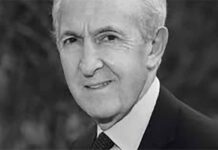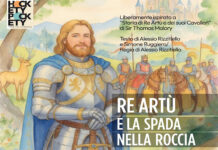A fine anno la Biblioteca degli Ardenti potrebbe riaprire al pubblico anche se sarà molto difficile per non dire impossibile. Perché se i lavori di risanamento e ristrutturazione stanno rispettando la tabella di marcia, la Burocrazia – nel senso più esteso del termine – rischia di compromettere, quanto meno ritardare, programmi e legittime aspirazioni di tutti coloro che hanno a cuore l’interesse e la valorizzazione del ricchissimo giacimento storico-culturale che si chiama Tuscia.
Dell’Accademia degli Ardenti e della sua Biblioteca resta comunque la storia incancellabile, autentica istituzione che affonda le proprie radici nel primo Rinascimento. Una storia che va riletta, attingendo nel nostro caso, a una tesi di laurea brillante e puntuale, svolta da Maria Rita Giuliobello all’Università degli Studi di Roma nell’anno accademico 1980/81. Storia, necessariamente raccontata in pillole. Tra la seconda metà del ‘400 e la prima del ‘500 Viterbo è, come scrive lo storico Giuseppe Signorelli, “una città quasi vuota di contadini e di ricchezze” che conta poco più di 4.000 abitanti. Nel 1546 papa Paolo III° Farnese apre una Università degli Studi che però ha vita breve, neppure 40 anni, per mancanza di studenti. Ma la città è comunque in forte espansione culturale con l’erudizione laica che va a integrare in modo sempre più massiccio e incisivo quella ecclesiastica. Alla fine del sedicesimo secolo Viterbo ha 70 chiese, 15 conventi, 9 monasteri, 1 conservatorio e 10 accademie, tante ne conta l’avvocato fiumano Michele Maylender. Ci sono le accademie degli Introvati, degli Imbiancatori, dei Capricciosi, dei Confusi, dei Divisi, degli Innominati, degli Ostinati, degli Smarriti, del Concilio e naturalmente degli Ardenti. Quest’ultima, già pensata dal Petrarca, nasce – siamo quasi alla fine del ‘400 – dall’iniziativa di Sante Cesara “perciocché se ne studiassero le antiche lettere, facendole note e accessibili agli spiriti più macerati…”. Ma la fondazione vera e propria, con tanto di stemma (verghe d’oro poste in un crogiuolo sopra a una fiamma che si consuma con il motto Donec Purum) viene attribuita, nel 1502, al parmense conte Antonio Tagliaferri. Lo scopo è quello di riunire gli appassionati delle più svariate branche della cultura e non solo: dalla poesia, alla scienza, dal teatro alla pittura, dalle professioni ai mestieri. Insomma, l’Intellighenzia che si riunisce…”per fare accademia”. Quella degli Ardenti è la più illustre e famosa della città e vive per oltre tre secoli, fino al 1870. Si aduna nel Palazzo di Città, all’angolo tra via Cavour e via San Lorenzo. Nel 1809 è divisa in quattro classi che offrono al meglio l’idea della fioritura degli studi: 1 scienze, 2 lettere e filologia, 3 antiquaria, storia, arti e mestieri, 4 commercio e agricoltura. Iscritti e “corrispondenti” rappresentano il fior fiore dello scibile e dell’arte, dall’Ariosto al Tasso, a Michelangelo. Giacomo Leopardi è affiliato nel 1817. L’elenco è lunghissimo. Nel 1821 viene inaugurata la nuova sede, sempre nel Palazzo Civico, con annesso Museo e Biblioteca. Una crescita che va di pari passo con il numero esagerato degli iscritti, ben 270. I componimenti, tra l’altro, risultano in qualche caso “troppo indecenti”, tanto da imporre al vescovo Severoli una severa censura. Viene stabilita quindi la chiusura delle iscrizioni per evitare un “avvilimento degli onori”. Una sorta di numero chiuso. La filosofia che si respira in Accademia è chiaramente progressista e certo non in linea con la Chiesa, comunque è ritenuta “asilo di elementi sovversivi mazziniani e liberaleggianti”, tanto che nel 1825 il cardinale Bertazzoli approva lo Statuto, ma con una clausola per gli iscritti e aspiranti tali: vanno “rigettati tutti quelli che possano ledere la religione, i costumi e i governi”. Nel 1831 il Delegato Apostolico arriva a vietare le adunanze accademiche e gli iscritti si riducono a 75. Chiaro segnale di una crisi che si acuisce ancora di più nel 1874 allorché l’amministrazione comunale guidata da Giacomo Lomellino d’Aragona fa approvare la soppressione di ogni sussidio a favore degli Ardenti. E’ praticamente la chiusura con una chiara motivazione: “il sodalizio in dissoluzione è divenuto arena di declamazioni antipatriottiche”. Novanta anni di silenzio poi, il 20 novembre 1963, la riapertura. Identico stemma con verghe e crogiolo sopra le fiamme e soprattutto immutabili le finalità dello Statuto: “studio, incremento ed esercizio di tutte le manifestazioni del pensiero, nonché elevazione culturale del popolo viterbese”.
Lo stemma della Accademia degli Ardenti in un acquarello di Andrea Scriattoli, ubicato nella Sala Regia di Palazzo dei Priori.